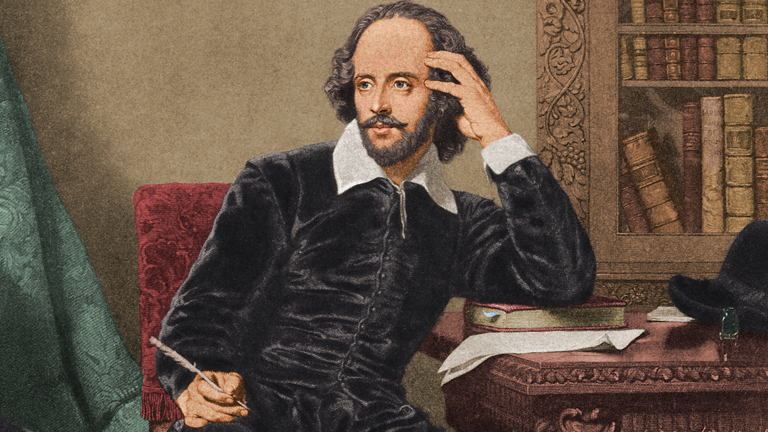Dopo il nostro servizio “Tanto rumore per… Shakespeare. Tutta la “non verità” sulla messinesità del Bardo – Il grande drammaturgo inglese era siciliano? , scritto dal docente di Letteratura e Linguistica Italiana presso la Concordia University di Montreal, Dario Brancato, pubblichiamo la risposta dell’architetto Nino Principato, che anticipa a Lettera Emme una sintesi del suo libro “William Shakespeare e la città di Messina”, di imminente pubblicazione. Nella pagina successiva troverete invece la controreplica di Dario Brancato.
La redazione di Lettera Emme, pur nell’apertura a tutti i contributi e nel rispetto della terzietà che intende avere nel dibattito, sposa la teoria della comunità letteraria mondiale, che ha bollato come inconsistente l’ipotesi che William Shakespeare possa essere messinese.
“William Shakespeare e la città di Messina”, di Nino Principato
Quando il prof. Martino Iuvara da Ispica (Ragusa) pubblicò, nel 2002, un volume intitolato Shakespeare era italiano in cui riprese le varie tesi esposte nel tempo, arricchendole con alcuni particolari inediti frutto di sue ricerche, chiarì il mistero del nome italiano del Bardo che, secondo lo studioso, era Michelangelo Florio, figlio di un medico e di una nobile siciliana, Guglielma Crollalanza, da cui la traduzione inglese di William Shakespeare.
“Crollare”, in italiano antico, significava “scrollare”, dimenare qua e là; quindi “crollalanza” è traducente perfetto di “shakespeare”. L’atto da cui deriva il cognome risale alla “Germania” di Tacito: “Si displicuit sententia, fremitu aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt. Honoratissimum adsensus genus est armis laudare (cap. 11)” (“Se il parere non è piaciuto, [i germanici in assemblea] lo respingono mormorando; se invece è piaciuto [s]crollano le lance. È il modo più onorevole d’approvazione, lodare con le armi.”). La voce “crollare”, nell’autorevolissimo Tommaseo-Bellini, dimostra indubitabilmente l’accezione antica di “crollare” che equivale al “concutio” tacitiano e allo “shake” scespiriano.
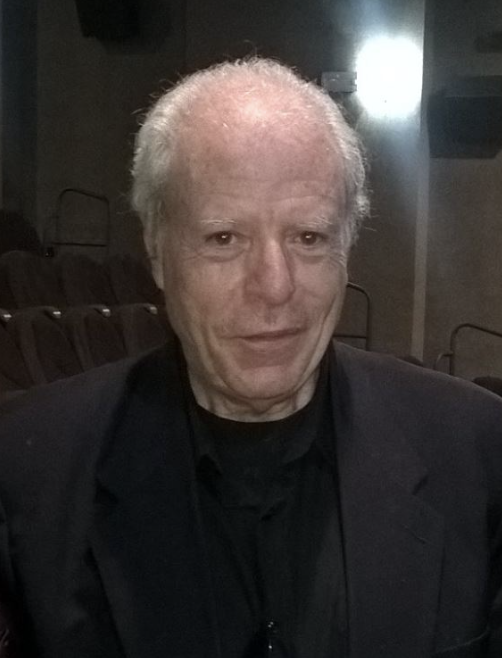
Nino Principato
Ecco, di seguito, ciò che sosteneva il professore ispicese. Michelangelo Florio, questo il presunto nome del grande drammaturgo, nacque a Messina il 23 aprile 1564 da Giovanni Florio (medico e pastore calvinista di origine palermitana) e dalla nobile Guglielma Crollalanza. Subito si rivelò un bambino prodigio, dotato di grande genialità e appassionato della lettura. A 16 anni conseguì il diploma del Gimnasium in latino, greco e storia. Giovanissimo, a conferma delle sue doti, scrisse una commedia in dialetto dal titolo “Tantu trafficu ppi nenti”. A motivo delle credenze religiose del padre, Michelangelo, non più al sicuro a causa dell’inquisizione, venne prima mandato in Valtellina e poi a Milano, Padova, Verona, Faenza e Venezia. Ebbe anche il tempo di tornare a Messina ma la sua permanenza nella città dello Stretto durò poco. A 21 anni Michelangelo iniziò il suo personale “giro del mondo”: soggiornò prima ad Atene, dove fu insegnante, poi in Danimarca, Austria, Francia e Spagna. Tornato ancora una volta in Italia, precisamente a Tresivio, s’innamorò di Giulietta ma la storia tra i due finì in tragedia con il rapimento, per motivi religiosi, e la successiva morte di quest’ultima. Sconvolto per la morte dell’amata, Michelangelo si trasferì a Venezia ma, dopo che anche il padre per le stesse ragioni fu trucidato, decise di mettersi in salvo trasferendosi a Londra. È qui che Michelangelo Florio cambia identità e diventa il famoso William Shakespeare. Lasciatosi alle spalle tutte le paure e i dolori precedenti, Shakespeare ebbe finalmente modo di dedicarsi a scrivere per il teatro. Le rappresentazioni dei suoi testi ebbero grande consenso tra il pubblico. Ma parte del merito del successo andava al dotto e letterato cugino John Florio, che lo aiutò nelle traduzioni dall’italiano all’inglese e alla moglie, sposata quando il drammaturgo aveva 28 anni, e di 8 anni più grande di lui. Superate le iniziali difficoltà legate al problema della lingua, Shakespeare s’impadronì perfettamente dell’inglese, coniando addirittura migliaia di nuovi vocaboli e arricchendo in maniera straordinaria la propria produzione letteraria. Divenne ricco, famoso e le sue opere molto apprezzate.

Fin qui la versione di Iuvara.
Dal canto nostro, da oltre un decennio abbiamo portato avanti la ricerca del professore ispicese giungendo a risultati che, definire sconcertanti, è dir poco. Ma andiamo con ordine. Intanto, alcune considerazioni.
Di William Shakespeare si conosce poco, ma molto poco. Si sa che divise la sua vita tra Londra e Stratford, dove si ritirò nel 1613 e dove sarebbe poi morto nel 1616. Di lui conosciamo la data di battesimo, 26 aprile 1564, ma con un altro cognome; nel registro parrocchiale di Stratford upon–Avon, infatti, si legge: “Gulielmus, filius Johannes Shakspere”. Proprio così, “Shakspere” e non “Shakespeare” che sono due cognomi completamente diversi. Il cognome Shakespeare appare dopo il 1593, cioè dopo la pubblicazione di “Venere e Adone”. Prima di allora esistevano altre versioni del suo cognome: Shagsper, Saxberd, Shaksper, Shakspere. Nei documenti matrimoniali del 1582 il cognome è scritto Shakspere e Shagspere: si tratta di due persone diverse, lo Shakspere di Stratford e lo Shakespeare drammaturgo? H. Carrirence, nel 1769, suppose che “William Shakspere, l’attore, e Shakespeare, lo scrittore, furono due differenti uomini”.
Gli unici esempi di scrittura di William Shakespeare che conosciamo sono sei firme quasi illeggibili, tutte posteriori al 1612 e nessuna relativa al periodo della composizione delle sue opere. Per un commediografo che ha scritto 37 fra tragedie, commedie e drammi storici è, francamente, un po’ troppo poco, per non dire assurdo. Oltretutto, nessuna firma ci è pervenuta per quel che riguarda le opere letterarie. Le sei firme, quasi una sorta di scarabocchi, sono relative: a una deposizione (12 giugno 1612, firma “Willm Shakp”); ad atti di transazioni immobiliari (10 marzo 1613, firma “William Shaksper” – 11 marzo 1616, firma “Wm Shakspe”); al testamento (25 marzo 1616, pagine 1, 2 e 3, firma “William Shakespeare”). Oltre ad alcuni particolari sui genitori di Shakespeare, gli storici sono inoltre in possesso del certificato di matrimonio di William, datato 27 novembre 1582, e dei certificati di battesimo dei suoi tre figli. Tutto qui! («[…] Gli elementi conosciuti sulla vita di Shakespeare si possono scrivere su di un lato di un foglietto per gli appunti», scrisse Mark Twain in “Is Shakespeare really dead?”, 1909).
Nei registri della scuola secondaria di Stratford, la “King’s New School” (la “grammar school” locale), non compare il nome di nessun William Shakespeare. Il grado d’istruzione raggiunto da Shakespeare rappresenta, ancora oggi, un enigma che non è giunto a soluzione. Sembra certo che non seguì un regolare corso di studi e nel “The Hermit’s Tale”, la cui ultima pubblicazione risale al 1613 ad opera dell’editore Thomas Thorpe e scritta da Humphrey King, l’autore dichiara che a mala pena era in grado di apporre la sua firma: Shakespeare non sapeva scrivere? Di lui, in effetti, come abbiamo detto, non rimane niente di scritto, tranne sei incerte firme e, del resto, i genitori erano analfabeti e firmavano con una croce. Susanna, la primogenita, a stento riusciva a firmare mentre la più piccola, Judith, era completamente analfabeta e firmava col “codino” (incredibile, ma vero!). I documenti della sua vita privata sono relativi a transazioni commerciali non scritti di suo pugno e soltanto tre recano la sua firma. Sono circa una settantina e tutti legati alle attività affaristiche di imprenditore e attore, citazioni per non aver pagato le tasse, per aver accumulato grano durante una carestia, citazione del 1612 dove viene definito, semplicemente, un “gentiluomo di Stratford” da un tribunale di Londra. Di manoscritti a carattere letterario, invece, non esiste niente; non scrisse mai una lettera, fatto stranissimo per uno che visse lunghi periodi della sua vita a Stratford e a Londra; non ebbe mai corrispondenza letteraria. John Aubrey, un biografo di Shakespeare, riferisce che “[…] if invited to writ he was in pain […]” (se invitato a scrivere, si faceva prendere dal panico). In effetti, dell’attività di Shakespeare drammaturgo si sa qualcosa solo a partire dal 1592, invece, si conosce molto della sua attività di impresario teatrale che lo avrebbe fatto arricchire (Robert Greene e Thomas Nashe, nonostante fossero laureati, condussero una vita di stenti). Shakespeare è l’unico scrittore inglese del suo tempo per il quale non ci sono prove contemporanee della sua carriera di drammaturgo. Tutt’altro, invece, sono documentate cause da lui intentate contro concittadini che gli dovevano modestissime somme di denaro e un’odiosa proposta di chiudere i terreni da pascolo comuni, unica fonte di sostegno economico delle famiglie più povere, che naturalmente fu respinta dall’amministrazione comunale di Stratford upon-Avon.
Il padre di William, John, era un guantaio, commerciava in lana e probabilmente faceva il macellaio. Proveniva da una famiglia illetterata di contadini e piccoli proprietari terrieri (yeomen). Il William Shakespeare gestore di una compagnia teatrale e uomo d’affari non molto scrupoloso, dedito persino all’usura, venuto al mondo in una famiglia di semianalfabeti e a sua volta padre di figli incolti, vissuto in ambiente grezzo e ineducato, si stenta ad identificarlo con il coltissimo drammaturgo.
Il drammaturgo Ben Jonson, amico e collega di Shakespeare, nel suo omaggio nel First Folio del 1623 afferma che i suoi lavori erano grandi, anche se aveva […] poca conoscenza del latino e meno del greco […]”, cosa che a quei tempi significava essere persona ignorante. Eppure, il Bardo aveva un’ottima conoscenza dei classici greci e latini, oltre alla letteratura francese, italiana e spagnola che certamente non aveva potuto acquisire da una carriera scolastica discontinua, insufficiente ed interrotta all’età di 13 anni. Si tenga anche presente che, a quei tempi, conoscere poco latino e greco equivaleva ad essere una persona incolta.
Quando muore, il 23 aprile 1616 nella sua casa campestre a New Place e viene seppellito nel coro della chiesa parrocchiale di Stratford “Holy Trinity”, nessuna commozione né lutto nazionale si registra in Inghilterra, quasi fosse uno straniero. Altri drammaturghi contemporanei come Ben Jonson e Francis Beaumont, ebbero funerali sontuosi e furono sepolti nell’abbazia di Westminster a Londra (Ben Jonson, addirittura, ebbe dedicati oltre cinquanta elegie commemoranti la sua scomparsa). Si pensi, inoltre, che quando morì Francis Bacon nel 1626, dieci anni dopo Shakespeare, in suo onore furono stampati e pubblicati ben 32 elogi. Nel caso di Shakespeare nulla di nulla, silenzio, era morto nessuno!
Lo scrittore inglese William Camden (1551–1623), nei suoi “Annali” (“Annales rerum Anglicarum et Hibernicarum regnante Elizabetha”, I vol. 1615, in inglese 1625; II vol., postumo, 1625, in inglese, 1629), per l’anno 1616 stranamente omette di menzionare la morte dello Shakespere di Stratford. Anche nella lista dei “Worthies Stratford” del 1605, Camden aveva omesso il suo nome e nel suo libro “Britannia” (1610) descrive ampiamente Stratford upon-Avon ma non parla mai di Shakespeare, neanche per citarne la sua nascita. Lo Shakspere di Stratford e lo Shakespeare drammaturgo, per Camden evidentemente non erano la stessa persona. E dire che Camden conosceva personalmente, e bene, Shakespeare, al punto che vi venne raffigurato insieme a lui in un dipinto ottocentesco.
Nel suo testamento del 25 marzo 1616 lascia alla moglie “[…] la seconda migliore camera da letto comprensiva di mobili.”; a dei suoi colleghi ventisei scellini a testa per comprarsi un anello di lutto; erede universale viene nominata la figlia primogenita Susanna; somme in denaro ed altri doni riserva alla seconda figlia Judith. Nel testo non c’è alcuna menzione di libri che pur Shakespeare dovette possedere, neanche una piccola biblioteca che sarebbe stata del resto insufficiente per un autore che dimostra, nelle sue opere, vastissime conoscenze storico-letterarie. Eppure, nei testamenti dell’epoca, veniva fatto un rigoroso e meticoloso inventario di tutti i beni posseduti, dipinti, sculture, mobili, gioielli, vestiti, libri ecc. La domanda ovvia che ci si pone è, dunque, da dove e come lo Shakespeare di Stratford apprese le lingue francese, italiano, spagnolo e danese? E i classici latini e greci? I manoscritti originali delle sue opere non sono stati mai trovati (assurdo se si pensa che, ad esempio, di Leonardo da Vinci vissuto dal 1452 al 1519, possediamo una mole enorme di manoscritti di suo pugno). Nel testamento di John Florio del 20 luglio 1625, posteriore di soli nove anni a quello di Shakespeare, salta subito agli occhi l’attenzione che viene riservata ai libri posseduti ed alla produzione letteraria: nessuna da parte di Shakespeare, nessun accenno all’immensa opera poetica cui aveva dedicato tutta la vita (evidentemente un semplice attore-commerciante non poteva accennare a ciò che non possedeva e che non aveva mai scritto); un ampio riferimento, invece, in John Florio, che si preoccupa perfino della futura destinazione della sua biblioteca.
Il brutto busto nel monumento funebre nella chiesa parrocchiale di Stratford, “Holy Trinity”, di fattura grossolana, venne realizzato fra il 1616 ed il 1623, probabilmente ad opera del genero di Shakespeare, John Hall, da uno scultore olandese, Gheerart Janssen. Il drammaturgo vi è rappresentato a mezzo busto, con la penna nella mano destra e la carta in quella sinistra e entrambe le mani appoggiate su un cuscino. La sua più antica raffigurazione venne pubblicata nell’opera di William Dugdale “Antiquities of Warwickshire” del 1656, e, successivamente, riproposta nella biografia di Shakespeare di Nicholas Rowe, nel 1709. In entrambi i disegni si vede chiaramente rappresentato un uomo con la barba e i baffi spioventi, che poggia le mani aperte e distese su un sacco di grano o di lana (e il padre dello Shakspere di Stratford era, notoriamente, “[…] un commerciante considerevole della lana”), simbolo efficace della sua professione, quella di mercante. Nel 1720 il busto venne clamorosamente modificato: il sacco fu trasformato in un elegante cuscino con nappe agli angoli, sul quale si trova poggiato un foglio tenuto dalla mano sinistra di Shakespeare, mentre la destra impugna una penna d’oca. Il mercante di grano o di lana è, così, diventato uno scrittore! I baffoni alla tartara sono adesso baffi eleganti e rivolti all’insù, la barba è scomparsa ed un pizzetto orna il mento del volto paffuto del personaggio. Una clamorosa mistificazione che ha fatto dire allo scrittore inglese John Dover Wilson (1881-1969) che il ritratto è quello di “[…] un macellaio soddisfatto di sé”. Il monumento, poi, contiene alla base una targa con una sgrammaticata iscrizione che fa riferimento generico a Shakespeare, non a William Shakespeare con nome e cognome per esteso, non allo scrittore, non a qualche sua opera, non alla sua attività teatrale e di drammaturgo.
E veniamo, adesso, finalmente al dunque.
La probabile origine messinese di William Shakespeare nasce da tutta una serie di considerazioni che hanno come denominatore comune la città dello Stretto, sia nella produzione letteraria del grande drammaturgo che nelle vicende della sua vita. La commedia teatrale Molto rumore per nulla (titolo originale: “Much ado about nothing”), ad esempio, scritta da Shakespeare tra il 1598 e il 1599, è infatti interamente ambientata a Messina e con personaggi tutti messinesi.
Shakespeare conosceva bene anche la storia romana e, particolarmente, quella messinese. Sapeva infatti che Pompeo aveva soggiornato a Messina nel 36 a.C.. Nella Commedia “Antonio e Cleopatra”, conoscendo questi fatti storici, parla della casa di Pompeo che è a Messina e proprio lì ambienta l’atto II scena I: “Messina. In casa di Pompeo. Entrano POMPEO, MENECRATE e MENAS, in assetto di guerra”.
In “Molto rumore per nulla”, Atto III Scena II, Don Pedro d’Aragona e Claudio hanno uno scambio di battute riguardanti Benedetto e la nipote di Leonato, Beatrice:
“PEDRO – E’ vero. Brutta storia. La conclusione è una sola: è innamorato.
CLAUDIO – E non è tutto. Io vi dico che so chi lo ama.
PEDRO – Vorrei tanto saperlo anch’io. Una che non lo conosce, ci scommetto.
CLAUDIO – Sì, invece, e conosce tutti i suoi difetti; e nonostante tutto si strugge per lui.
PEDRO – La seppelliranno col viso in su.” (traduzione di Masolino d’Amico).
Letta così, la frase pronunciata da Don Pedro “La seppelliranno col viso in su” [“She shall be buried with her face upwards”, in altre traduzioni “E allora sarà seppellita con la faccia all’insù” (traduzione di Gabriele Baldini)] sembra non avere alcun significato razionale. È infatti risaputo che i morti vengono deposti nella bara e sepolti in questa posizione. Per comprendere a fondo il vero significato di questa frase sibillina e assurda, occorre fare riferimento a un modo di dire esclusivamente messinese: ancora oggi, infatti, di una persona superba nonché scaltra si dice in dialetto che “avi a nasca addritta” (“ha il naso tirato in alto, all’insù). Paragone che si attaglia perfettamente al personaggio di Beatrice innamorata di Benedetto, ma talmente orgogliosa, appunto col naso all’insù, da esserlo anche dopo morta. Come faceva l’inglese William Shakespeare a conoscere questa metafora strettamente messinese e sconosciuta in Inghilterra?
Ancora in “Molto rumore per nulla”, atto IV scena I, Beatrice dice a Benedetto: “O God, that I were a man! I would eat his heart in the market-place!” (“Ah, Dio, se fossi uomo! Gli mangerei il cuore sulla piazza del mercato!”). Ebbene, anche tale modo di dire è tipicamente messinese e certamente sconosciuto a un inglese. A Messina, la rabbia rivolta verso chi ci ha fatto un torto grave viene eloquentemente sintetizzata, appunto, nella frase “ti manciria ‘u cori” (“ti mangerei il cuore” ) aggiungendo, a volte, anche “bagnatu ‘o Sali” (“bagnato col sale”).
E allora? “Essere messinese, o non essere inglese, questo è il dilemma”.
Nino Principato
Nella pagina successiva la controreplica di Dario Brancato