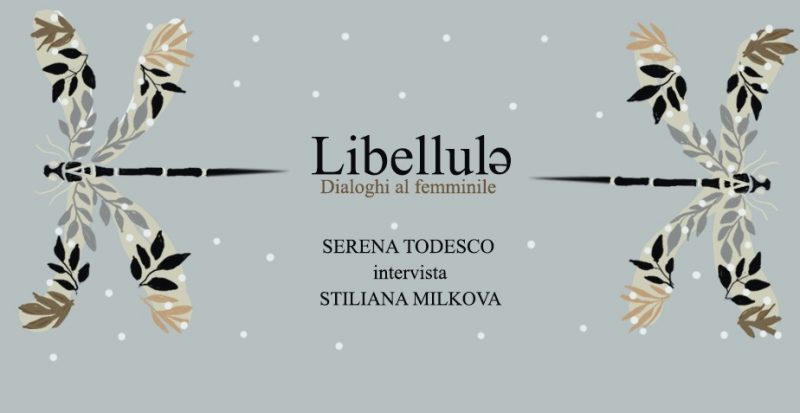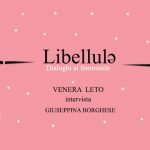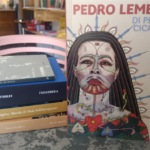“Libellulə” è un progetto che nasce dalla sinergia e dalla contaminazione di quattro donne: Silvia Grasso, Venera Leto, Laura Lipari e Serena Todesco (bio in calce). Attraverso la ricerca, la scrittura, i libri e la passione l’intento comune è far emergere aspetti poco noti del mondo letterario femminile e in generale di soggettività che vengono relegate ai margini. L’obiettivo è porre un focus su tematiche attuali e far riflettere sulla necessità di instaurare un dialogo tra i generi e modificare alcuni retaggi culturali. Il titolo è un omaggio a “La Libellula” di Amalia Rosselli ed è un augurio di leggerezza ed equilibro per chiunque lotti per la propria autodeterminazione. Di seguito la seconda puntata.

Serena Todesco intervista Stiliana Milkova
Storia delle prime volte (Voland 2022) è una resa dei conti poetica e struggente che Stiliana Milkova compie nei confronti della lingua e della letteratura del nostro Paese. Le protagoniste di questi dieci racconti sono donne nomadi, prima di tutto capaci di vagare mentalmente tra gli spazi, brave a intravedere gli interstizi delle situazioni, le zone ferrantianamente “smarginate”, le possibilità di ritrovare una voce dentro lingue e luoghi meno stranieri di quanto si pensi.
Come sei arrivata alla scelta di scrivere in italiano?
Per rispondere dovrei raccontare come sono arrivata all’italiano. Il mio è stato un percorso lungo e frammentato, spesso interrotto per anni e poi intrapreso di nuovo. Ho cominciato a studiare l’italiano molto tardi, stavo finendo la tesi di dottorato in letterature comparate e slavistica presso Berkeley e volevo leggere un testo scritto in italiano da uno scrittore bulgaro esiliato a Firenze nel tardo Ottocento. Ho fatto qualche corso di lingua a Berkeley, ho studiato per un mese all’Università per Stranieri di Siena, poi ho smesso. Anni dopo ho ripreso di studiare l’italiano, ho fatto corsi all’Istituto Italiano di Cultura a Chicago, poi un mese all’Università per Stranieri di Perugia. Leggevo molto, avevo un’intera tradizione letteraria da conoscere, non mi davo tregua. E leggendo ho iniziato a tradurre. Ho tradotto in inglese cinque racconti di Antonio Tabucchi e mi sono accorta che la traduzione è la migliore formazione linguistica e letteraria. Ho tradotto altri testi, altri scrittori, e traducendo, ho iniziato a scrivere in italiano – sentivo la lingua vicina, capace di esprimere ciò che non riuscivo a dire in inglese. Scrivere in italiano non è stata una scelta deliberata e consapevole; anzi, la scrittura in italiano è nata senza avvertimento ma anche senza esitazione, in modo naturale ed organico – come se non potessi farne a meno. Sebbene non abbia mai vissuto in Italia, mi sento a casa nell’italiano. Come me lo spiego? Sono di madrelingua bulgara, sono nata e cresciuta in Bulgaria, ma da parecchi anni lavoro e scrivo in un mondo anglofono, lontana dal mio paese e dalla mia lingua. L’italiano paradossalmente mi ha riportato al bulgaro, le due lingue (nonostante gli alfabeti diversi) sono affini – la sintassi e la grammatica sono vicine. In quanto studiosa direi che l’italiano nel mio caso funziona come “terzo spazio” ma anche come “eterotopia”, un luogo che contiene tutti gli altri luoghi…Il linguaggio accademico da parte, l’italiano semplicemente mi piace!
Nei tuoi racconti ci sono spesso donne che viaggiano in luoghi stranieri e li utilizzano come estensioni delle proprie fantasie e desideri, ma soprattutto esprimono forme di dis-appartenenza. Bisogna essere stranieri, secondo te, per esperire un luogo in modo obliquo e imprevisto?
Hai ragione – i miei personaggi viaggiano in luoghi stranieri e, incontrando l’ignoto, affrontano le proprie fantasie e desideri ma in una forma sconosciuta (e in una lingua straniera). Quindi il viaggio è sempre anche un attraversamento del loro paesaggio psicologico. Dall’altro canto, la sensazione di sradicamento, di dis-appartenenza, proviene dalla oscillazione fra le lingue, identità e realtà diverse che costituiscono il tempo e lo spazio dei protagonisti. Racconto storie e situazioni che conosco bene, le trame scaturiscono dalla mia esperienza multilingue che però non è per nulla unica o rara – spostarsi fra lingue e paesi (per qualsiasi motivo) è la realtà odierna del nostro mondo globalizzato. E comunque ormai è diventato quasi de rigueur nell’ambito accademico parlare o scrivere di identità ibride, di esofonia e translinguismo. (Al proposito, ho scritto i racconti che poi ho raccolto in Storia delle prime volte nell’arco di due o tre anni e poi sono rimasti nel cassetto ancora per anni, non hanno molto a che fare con la saggistica di oggi.) Non bisogna essere stranieri per esperire un luogo in modo obliquo e imprevisto; bisogna essere aperti e flessibili per poter abbandonare le cornici stabilite e guardare e sentire senza il conforto o la protezione dell’abitudine mentale. Bisogna non essere perfezionisti e liberarsi dall’auto-censura eppure praticare un’auto-sorveglianza – come fanno, per esempio, le protagoniste di “Via delle Puttane” e “La ragazza che amava viaggiare”.
Quanto è stato decisivo il ruolo della traduzione nel tuo percorso di scrittura, o anche in ciò che Goliarda Sapienza chiama “il baule mentale”?
I corsi di traduzione insegnano che la traduzione è scrittura creativa, che un traduttore dev’essere in primo luogo un bravo scrittore per riuscire a ricreare il testo nella propria lingua. Per me è stato al contrario. Ho iniziato a scrivere poesie e racconti in italiano spinta dall’energia, dalla forza creativa, che sprigiona la traduzione. Ovvero sono stata una traduttrice prima di diventare una scrittrice. E traduco fra lingue che non mi appartengono – ho imparato l’inglese al liceo in Bulgaria, l’italiano da dottoranda quasi trentenne negli States (e lo sto imparando ancora). Ma forse proprio per questo la traduzione come pratica e come metafora è un’immagine chiave nella mia scrittura. Le mie protagoniste sono traduttrici di mestiere oppure si trovano in situazioni in cui devono mediare, tradurre, inventare sé stessi in un contesto straniero. Il mio ‘baule mentale’ è un luogo fisico, magico, non solo immaginario – la soffitta della casa dei nonni a Burgas, al Mar Nero – uno spazio colmo di libri, di quadri, di oggetti-ricordi, di emozioni e di storie. Le mie infanzia e adolescenza sono trascorse là, in quella casa accanto al parco marittimo e alla spiaggia. Ne scrivo un po’ anche nel libro e anche in altri racconti che ho scritto dopo Storia delle prime volte.