MESSINA. Non era sufficiente, a quanto pare, l’accordo trovato a novembre 2021 fra la Soprintendenza e il Comune di Messina per finalizzare il restauro della Fontana di Orione: una settimana fa, infatti, le parti interessate hanno firmato un nuovo schema di convenzione, che prevede più o meno quello che già prevedeva l’accordo di quattro anni fa (solo che impegna nero su bianco anche l’Opificio Pietre Dure di Firenze). Eppure, la notizia assume un tono trionfale, lo stesso che aveva avuto l’annuncio dell’ex sindaco Cateno De Luca nel 2019 (quindi ben sei anni fa) di un restyling del monumento cinquecentesco del Montorsoli. In questi anni, ogni piccolo step sembrava l’ultimo per arrivare finalmente all’obiettivo, quello di rimettere a nuovo la fontana più bella del Rinascimento europeo, fino a quando, a settembre 2023, non era stata “liberata” dai pannelli che la occultavano, lasciando intravedere la fine del tunnel (qui l’articolo).
“Si tratta di un passaggio decisivo che ci consente di entrare nel vivo delle attività grazie al coinvolgimento delle massime competenze del settore: la Soprintendenza di Messina e l’Opificio delle Pietre Dure, che garantirà un supporto scientifico di altissimo livello”, dichiarava il 2 aprile il vicesindaco Salvatore Mondello, come se l’accordo del 2021 non ci fosse mai stato. E cosa prevedeva questo accordo? In estrema sintesi, il Comune di Messina avrebbe appaltato i servizi della diagnostica, prodotto i risultati delle indagini e messo materialmente le risorse; la Soprintendenza, invece, avrebbe fornito il progetto esecutivo di restauro seguendo le linee guida dettate dall’Opificio Pietre Dure e svolto la funzione di direzione lavori nei cantieri.
Il nuovo schema di convenzione è praticamente uguale: il Comune di Messina deve affidare l’incarico all’ingegnere strutturista per la revisione e l’analisi delle indagini diagnostiche già eseguite, la valutazione della stabilità strutturale tramite la valutazione complessiva del sistema fontana, la progettazione e direzione lavori dell’intervento di messa in sicurezza e consolidamento strutturale con l’individuazione di soluzioni per migliorare l’ancoraggio e il collegamento degli elementi lapidei e la predisposizione del cantiere per la movimentazione e le lavorazioni in sicurezza. E tutto questo è già stato fatto, inclusa la condivisione delle analisi dei risultati con la Soprintendenza e l’Opificio. Inoltre, come già previsto dal precedente accordo con la Soprintendenza, deve sostenere gli oneri finanziari e appaltare i lavori di restauro.
Dall’altra parte, la Soprintendenza mantiene anche le stesse competenze, a braccetto con l’Opificio: “fornire all’Ente in collaborazione con l’OPD il progetto di restauro della fontana Orione“. E come il precedente accordo, la convenzione stabilisce che la Soprintendenza svolgerà la funzione di direzione lavori e direzione scientifica nel cantiere, aggiungendo, però, che l’Opificio dirigerà i lavori e assumerà la direzione scientifica nel cantiere per il solo restauro delle superfici lapidee.
«Eravamo ancora nella fase di analisi, adesso siamo nella fase esecutiva», spiega il vicesindaco Salvatore Mondello sul nuovo accordo, anche se non si espone fornendo delle tempistiche: «Soprintendenza e Opificio non hanno un termine per ultimare il progetto. Solitamente si fa in 60 o 90 giorni, ma trattandosi di un progetto importante su un’opera delicata ci vorrà il tempo che ci vuole».
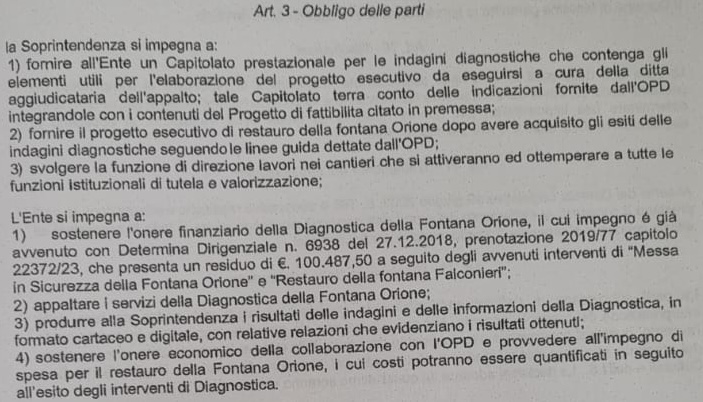
Accordo firmato nel 2021
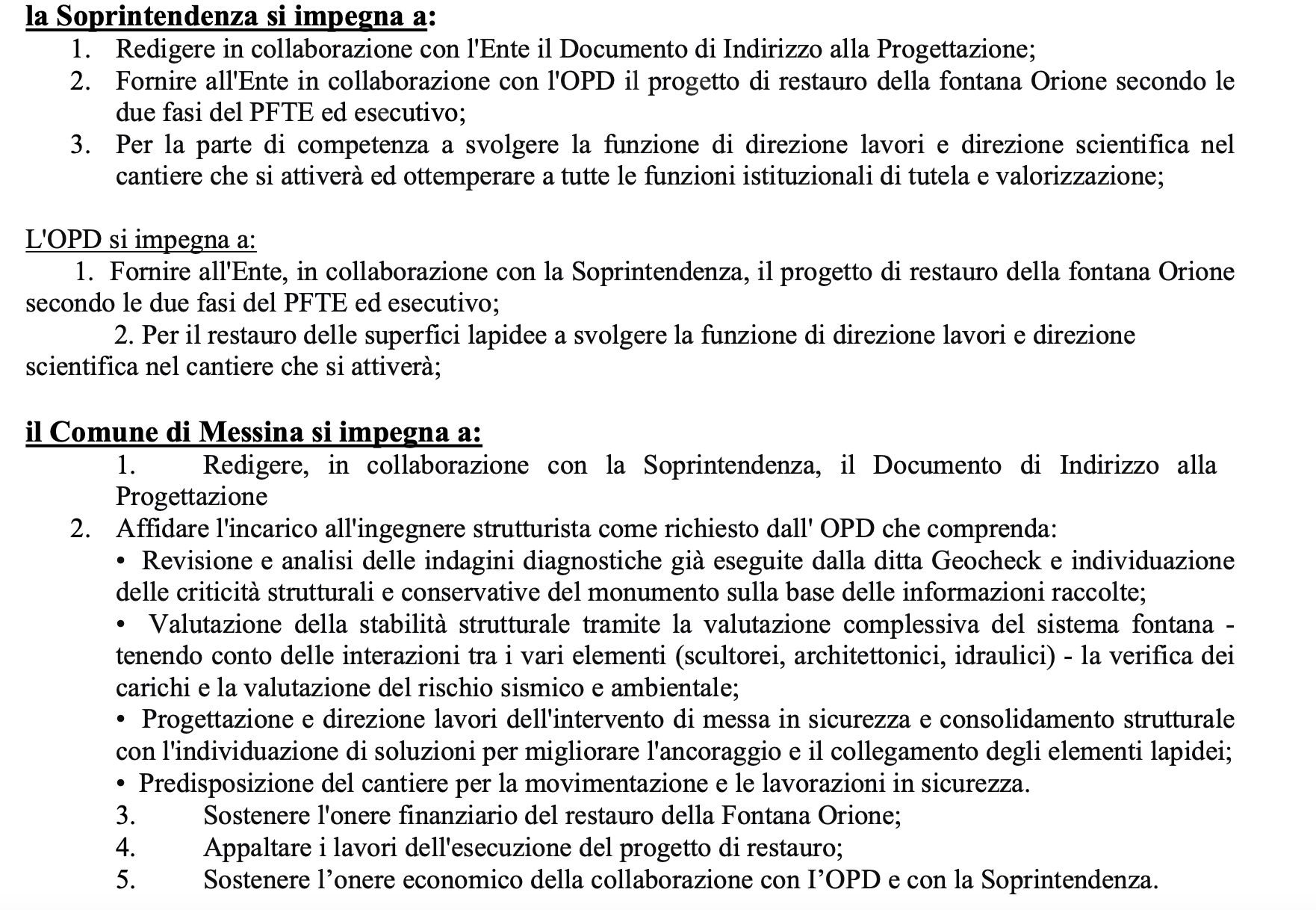
Convenzione firmata mercoledì (2 aprile 2025)
A settembre 2023 le impalcature dalla fontana erano state rimosse perché si erano concluse le indagini diagnostiche che dovrebbero portare alla realizzazione di un modello 3D che rappresenterà la mappatura completa del degrado e consentirà una dettagliata progettazione del restauro successivo. Quindi, si è ancora in questa fase: i lavori non sono ancora iniziati e la Soprintendenza e l’Opificio, secondo gli accordi, devono fornire il progetto seguendo le linee guida redatte precedentemente dallo stesso Opificio e i risultati delle analisi che si sono concluse nel 2023 (e che il Comune di Messina ha già condiviso). Una volta consegnato il progetto, il Comune potrà lanciare finalmente la gara d’appalto e, una volta completata questa, i lavori potranno iniziare
Come sono state svolte le indagini? Georadar, termografia, tomografia elettrica, endoscopia, ultrasuoni, analisi di laboratorio fisico-chimiche e valutazione della vulnerabilità sismica del monumento, proprio secondo le linee dettate da una relazione dell’Opificio Pietre Dure di Firenze: «Rilievo geometrico e di dettaglio della fontana, mediante scansione tridimensionale e fotogrammetria (SFM); Restituzione e rappresentazione grafica, modellazione 3D dei dati; Rilievo morfologico dimensionale sia della parte fuori terra che della parte interrata (quest’ultima utile ai fini della progettazione del consolidamento della pila centrale della fontana); Rilievo dello stato fessurativo e delle lesioni presenti; Indagini termografiche per individuare difetti strutturali non percepibili o non perfettamente visibili ad occhio nudo; Indagini radar per determinare la posizione degli inserti metallici all’interno del marmo e le discontinuità strutturali; Indagini dello stato di rilassamento e di discontinuità interne con test a ultrasuoni corredati da elaborazioni grafiche; Indagine endoscopica per individuare lo stato di degrado delle tubazioni che corrono all’interno della fontana, il loro percorso e i materiali che costituiscono il sistema idraulico; Indagini geognostiche del basamento e delle fondazioni (georadar), finalizzate a precisare le caratteristiche dei terreni e le geometrie dei materiali di fondazione, anche con rilievi endoscopici; Indagini geologiche del cunicolo interrato».
Con una determina di venerdì 14 ottobre 2022 il Comune di Messina aveva dato il via libera alla gara d’appalto e affidare la famosa “fase diagnostica” (qui il link alla notizia), ovvero quelle indagini propedeutiche alla fase di progettazione per il restauro del monumento che più volte erano state annunciate, scaricando addirittura il lavoro sull’Opificio Pietre Dure di Firenze che, invece, non ne sapeva nulla. Con una delibera di Giunta di novembre 2021, infatti, l’Amministrazione e la Soprintendenza dichiaravano di aver raggiunto un accordo per affidare il progetto esecutivo, dopo la fase diagnostica basata proprio sulla relazione dell’Opificio (qui l’articolo). Il problema era che la strutta fiorentina non aveva idea di doversene occupare, perché con la relazione del luglio dello stesso anno sostenevano (e così era) di aver terminato il proprio lavoro e spiegavano chiaramente come nell’opera del Montorsoli fossero presenti problemi a livello strutturale, consigliando di rivolgersi ad altri esperti. E infatti, a dimostrazione di ciò, ad un anno e qualche mese da quella relazione arrivava la determina per lanciare la gara d’appalto che affida quella “fase diagnostica”, per cui sono stati previsti centomila euro e di cui se ne occuperà la ditta che si aggiudicherà l’affidamento delle indagini.
Dopo il sopralluogo di luglio 2021, infatti, era stata redatta una relazione dove si accennavano i problemi del prestigioso monumento cinquecentesco: di carattere strutturale e per cui «abbiamo consigliato di rivolgersi ad un ingegnere strutturista», spiegava Simone Forcinai, chimico dell’Opificio Pietre Dure di Firenze che si occupa di analisi sui beni culturali. Per i fiorentini il lavoro era terminato lì. E spiegavano di non essere stati ricontattati per nessun altro incarico. Sulla questione era intervenuto anche il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo, con un’interrogazione rivolta al commissionario straordinario Leonardo Santoro, subentrato al sindaco dimissionario De Luca (qui il link).
Fase diagnostica che si attendeva ormai da agosto del 2019, quando la Soprintendenza non aveva permesso all’Amministrazione di mettere le mani sulla fontana per farla analizzare dall’Opificio Pietre Dure di Firenze. L’incontro con i fiorentini è tardato causa impegni della struttura toscana e causa covid. Ma poi è arrivato e si è giunti a tutt’altra conclusione rispetto a quella fornita dall’Amministrazione qualche mese fa. Nella delibera di Giunta di novembre si annunciava in maniera trionfante un accordo trovato fra Palazzo Zanca e la Soprintendenza di Messina, proprio sulla base della relazione dell’Opificio. Cosa prevedeva? Una ripartizione delle competenze fra i due enti, messe nero su bianco: il Comune di Messina impegna materialmente le risorse e appalta i lavori per la “fase diagnostica”, la Soprintendenza fornisce il progetto esecutivo di restauro (qui l’articolo completo).
L’Opificio aveva già fornito le linee guida sulle quali verrà realizzato il progetto dopo aver effettuato la “fase diagnostica”, sosteneva la Soprintendenza, anche se di questa fase non si aveva alcuna notizia, visto che i fiorentini nella relazione indicavano solo dove dovrebbe concentrarsi la campagna di indagini: le verifiche sono altri a doverle effettuare, ovvero degli ingegneri strutturisti. «Durante il sopralluogo si è potuto constatare che le maggiori criticità si manifestano sul gruppo delle Naiadi: numerose fratture si dipartono dalla pila centrale e attraversano il monolite interessando, soprattutto, due delle figure – si leggeva nella relazione – Il dissesto sembra avere origine alla quota dove la vasca, collocata subito sopra il gruppo scultoreo, insiste sull’elemento centrale. Le fratture, già presenti e documentate nelle immagini risalenti al restauro del 1992, appaiono progredite e si registra un disallineamento dei frammenti marmorei. La concentrazione delle lesioni su uno dei fronti ed una leggera inclinazione che sembra di percepire osservando la vasca, ci conducono a ipotizzare che il dissesto possa essere dovuto ad uno stress meccanico da trazione/compressione; lo sbilanciamento dell’invaso causerebbe una ridistribuzione non controllata del carico ed una focalizzazione degli sforzi con un conseguente collasso del materiale lapideo. Per motivare l’eventuale inclinazione assunta dalla vasca sarebbe utile procedere con accertamenti sul tipo e sulla consistenza del sistema di fondazione, in un volume significativo di sottosuolo, e conseguentemente con lo studio della stabilità del sito in cui ricade la fontana», continuavano i tecnici nella relazione, che pertanto ritenevano «necessario il coinvolgimento di un ingegnere strutturista con comprovata esperienza nel campo del restauro dei beni culturali che possa definire con precisione e coordinare la campagna di indagini volta ad accertare il livello di danno della struttura e prevederne la sua evoluzione nel tempo. Sulla base di quanto è stato possibile osservare durante il sopralluogo si consiglia una campagna di indagini conoscitive utili a definire le cause delle lesioni nel gruppo delle Naiadi e dei soprastanti elementi scultorei», spiegavano.
Da cosa derivano i problemi del monumento secondo l’Opificio? «Il terremoto del 1908 e gli interventi di restauro che ne sono conseguiti, in particolare quello del 1923-1924, hanno determinato una profonda trasformazione dell’assetto originario della fontana con l’inserimento di numerosi vincoli metallici e tasselli integrativi. La presenza dell’acqua ha rappresentato un fattore aggiuntivo di vulnerabilità per le forme di degrado che essa induce. Non trascurabili sono, inoltre, i danni dovuti ai tensionamenti dell’impianto idraulico interno alla struttura. La fontana, in ragione della sua esposizione, subisce una notevole escursione termica; il diverso coefficiente di dilatazione del metallo delle tubazioni rispetto al materiale lapideo è una delle cause che conduce a tali tensioni».





