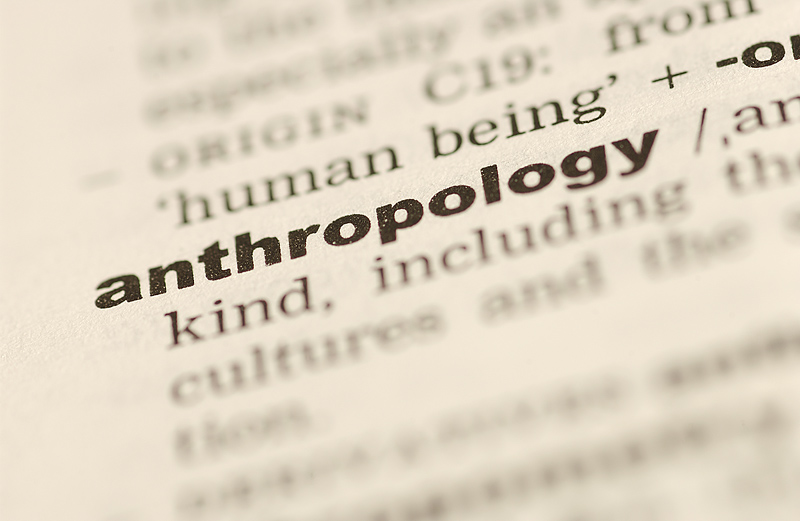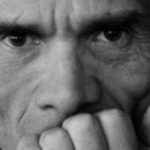Un acuto intervento di Salvatore Bottari (Violenza contro le donne, migranti, un commento infame etc., su Facebook) riguardante alcuni recenti e sconcertanti episodi di violenza fisica e ideologica (uno stupro di massa e la sua misogina giustificazione ad opera di un sedicente mediatore culturale) mi ha fatto ancora una volta riflettere sulla pregnanza del pensiero di quello che io considero il più importante antropologo italiano, Ernesto de Martino, le cui riflessioni sui destini e sui compiti dell’Occidente avevano a suo tempo animato vivaci polemiche.
Cosa notava giustamente Bottari? Che la nostra sacrosanta lotta contro ogni forma di razzismo e di discriminazione non deve impedirci di scorgere i semi di barbarie presenti in alcune forme di cultura dei popoli “altri” con i quali sempre più l’Occidente viene a contatto e con i quali sempre più lo stesso Occidente, com’è giusto e ormai fatale anche se molti sembrano non accorgersene, dovrà imparare a convivere pacificamente, sperimentando forme più o meno soddisfacenti di integrazione.
Qualche esempio di tali “semi di barbarie”? La pratica dell’infibulazione, o la concezione della donna quale essere inferiore o “animale sensitivo”, la violenza embricata all’esercizio delle fedi religiose o il sistema delle caste, etc., fino a giungere alle fandonie di un Imam che promette ai terroristi suicidi la deflorazione di centinaia di vergini il cui imene viene prontamente rimesso a nuovo per consentir loro di continuare ad abusarne.
È chiaro che tutte quelle sopra elencate sono forme di cultura elaborate in seno a contesti assai diversi dai nostri, e sarebbe ridicolo pensare di poterle cambiare dall’esterno in forza della loro “carenza di umanesimo”. Abbiamo già in passato provato ad esportare tante volte la democrazia (sic), e si è visto con quali risultati! Anche perché avevamo nei secoli precedenti esportato tante altre cose, dallo schiavismo alle malattie alle forme brutali di dominio, e in epoca post-coloniale dalla vendita di armi alle guerre civili indotte per consentire alle multinazionali di continuare nell’esercizio dello sfruttamento.
D’altra parte, non deve destare scandalo o sorpresa particolari la constatazione che le scelte fatte nel tempo dai diversi gruppi sociali sparsi nel pianeta siano stati diversissimi e molto spesso abbiano contraddetto l’idea, tutta occidentale, di progresso. Claude Lévi-Strauss, il maggiore antropologo del XX secolo, in un famoso saggio degli anni ’50 aveva già messo in dubbio la concezione unilineare e progressiva dello sviluppo delle civiltà: “L’umanità in progresso non assomiglia certo a un personaggio che sale una scala, che aggiunge con ogni suo movimento un nuovo gradino a tutti quelli già conquistati; evoca semmai il giocatore la cui fortuna è suddivisa su parecchi dadi e che, ogni volta che li getta, li vede sparpagliarsi sul tappeto, dando luogo via via a computi diversi. Quello che si guadagna sull’uno, si è sempre esposti a perderlo sull’altro, e solo di tanto in tanto la storia è cumulativa, cioè i computi si addizionano in modo da formare una combinazione favorevole” (Race et Histoire, 1952).
Tanti modi di declinare l’umano, quindi. E tante tare equamente distribuite all’interno. Ma essere consapevoli delle tare che la nostra civiltà ha prodotto nel corso dei secoli non deve impedirci di scorgere anche ciò che di positivo l’Occidente è riuscito a elaborare, con molta fatica certo, attraverso guerre, rivoluzioni, sconvolgimenti ideologici e mutazioni di costume, ma giungendo infine a costruire un umanesimo, una patria comune in cui sia valore in larga misura condiviso che l’uomo non sia lupo per i propri simili.
L’”etnocentrismo critico” di cui parlava Ernesto de Martino si proponeva certamente l’allargamento della coscienza culturale dell’Occidente di fronte alle sfide costituite dall’incontro etnografico con culture diverse, attraverso l’acquisizione di una consapevolezza critica dei limiti della propria. L’etnocentrismo critico mette in discussione “le stesse categorie di osservazione di cui lo studioso dispone all’inizio della ricerca”. Con questa tensione etico-speculativa si può realizzare, secondo de Martino, quell’umanesimo etnografico che implica un’opera di storicizzazione di sé e della propria cultura, e di riflessione critica sul proprio télos. Tale tensione non comportò mai però per lo studioso la rinunzia a credere in un primato della civiltà occidentale, i cui modelli più avanzati, costruitisi faticosamente attraverso una lunga e sofferta storia culturale che dai filosofi greci al diritto romano, dal Cristianesimo all’Umanesimo e al Rinascimento, dall’Illuminismo al Socialismo all’Idea liberale (nei loro motivi di verità), e finanche – aggiungo io – al voto alle donne, al Sessantotto, al movimento ecologista e alla teoria della decrescita felice, era giunta a riconoscere il valore centrale della persona umana. Il modello della civiltà “europeo-occidentale” appariva a de Martino, in questo senso, più avanzata non tanto sul piano del sapere scientifico, della tecnologia e dello sviluppo culturale, quanto su quello dei diritti umani e della scoperta della origine e destinazione integralmente umane di tutti i beni culturali.
“Che si debba mantener fede alla ragione, come télos dell’umanità rappresentato in modo eminente dall’Occidente, o che si debba invece abdicare davanti all’irrazionale e tornare a fare di esso il tema fondamentale della vita: questa alternativa si chiama Europa, poiché noi europei la stiamo vivendo con una drammaticità che non ha l’eguale in nessuna altra civiltà del nostro pianeta. Che il viver civile debba essere ordinato secondo le forme di una democrazia socialista o debba sostanzialmente muoversi nel margine di scelte possibili per entro la democrazia borghese, anche questa alternativa si chiama Europa, perché in Europa ebbero le loro radici le condizioni sociali e la tensione di pensiero che prepararono questi due messaggi, che oggi polarizzano intorno a sé le altre umanità dell’ecumene. Il prodigioso sviluppo delle scienze e la attuale prospettiva della conquista degli spazi cosmici si chiama ancora Europa, da Galileo a Einstein: le altre civiltà non ci propongono a questo riguardo nulla di radicalmente nuovo e più alto, ma, se mai, scelte per noi improponibili come, per esempio, il viaggio psichico degli sciamani asiatici verso i superi e versi gli inferi, o la sapienza dei Veda, o quella di Confucio, o lo Yoga o il Buddhismo Zen, per tacere dei vari occultismi europei, cui indulgono le anime stanche e i cervelli deboli. Senza dubbio il naturalismo e il tecnicismo costituiscono per noi un pericolo mortale, in quanto perdono l’uomo nel mondo delle cose e ne compromettono il ritorno a sé, la presa di possesso di sé, lo scoprirsi come margine oltre la natura, insomma tutto quanto fonda l’umanità occidentale come ethnos operativo. Ma contro questo pericolo la difesa sta nella storia interna dell’Occidente, cioè nel far progredire la “ragione” oltre i limiti storici in cui sinora l’Occidente ne ha avuto coscienza. Abbandonare la ragione e abbracciare sistemi di scelte estranei al suo télos, non diremmo che l’Europa non possa, ma certo non deve: e non deve perché le scelte culturali non sono arbitrarie, permutabili a piacere, ma formano coerenze e fedeltà che comportano anche rinunzie definitive.” (Promesse e minacce dell’etnologia, 1962)
Non si possono mettere sullo stesso piano quindi tutte le declinazioni dell’umano prodottesi nel pianeta nel corso del tempo. E la civiltà europeo-occidentale (io credo anche per merito di un giovanotto che ha calcato la terra di Galilea duemila anni fa) è quella che a conti fatti ha prodotto una riflessione come quella, famosa, attribuita a Voltaire sul rispetto delle idee e delle libertà altrui, anche quando non condivise (ma, aggiungerei, a condizione che non siano lesive della dignità di chiunque).
Insomma, come anni fa notava Guido Vitiello in un suo blog, c’è il rischio che a forza di fustigare l’etnocentrismo si finisca col diventare etnocentrifughi!
Le anime belle che, per proprio ingenuo convincimento, per essersi imbevute oltremisura di filosofie New Age o semplicemente per conformistica moda veicolata dai social network, ritengono che tutto quanto proviene da fuori debba avere sempre e in ogni caso giustificazione e diritto di cittadinanza, testimoniano in realtà come l’Occidente, oggi fatto segno di una strisciante mutazione neo-capitalistica (di un capitalismo finanziario cieco e anodino, che appare tuttora rampante ma che io prefiguro crepuscolare), rischi di smarrire ogni reale sentimento del tempo, dei tempi della propria storia e di quelli che ne sono stati i frutti migliori.