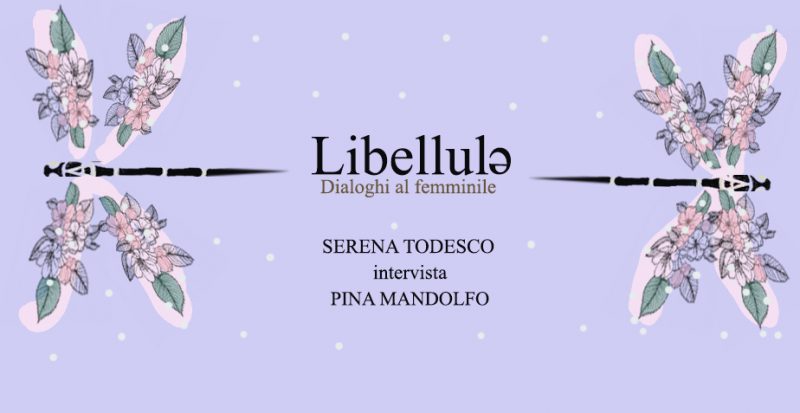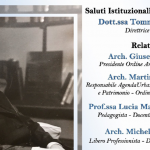di Serena Todesco
Pina Mandolfo, originaria di Belpasso (in provincia di Catania) è scrittrice, regista e sceneggiatrice, oltre che socia fondatrice della Società Italiana delle Letterate. Il suo percorso nel femminismo porta il segno di uno spirito eclettico, capace di sondare e attraversare diversi ambiti creativi, mantenendo viva la strada del pensiero critico e di un’arte consapevole, attiva nel racconto di vite femminili. Nei documentari dedicati alla violenza sulle donne, alle questioni legate al Sud e alla mafia, così come nelle storie che gettano ponti preziosi tra passato e presente – l’ultima è la vicenda della principessa Anna Valdina, protagonista del romanzo Lo scandalo della felicità (Vanda Edizioni, 2023), il suo sguardo lucido di narratrice su carta o su schermo ha saputo intrecciare intuizioni di chiara valenza sociale e politica a forme di racconto tese a rivitalizzare un passato sepolto da riscoprire.

Foto dai siti Letterate Magazine e Festival delle letterature migranti
Cara Pina, questa piccola intervista vorrebbe toccare, o almeno sfiorare, la sostanza del tuo talento poliedrico di scrittrice, regista, sceneggiatrice e promotrice del lavoro femminile sotto il segno di un femminismo consapevole, concreto e appassionato, mai ideologico. La mia
prima domanda riguarda un tema enorme, ovvero da dove nascono le tue storie. Che tipo di processo avviene in te? Le personagge e i personaggi vengono loro da te insistendo per parlare, come ci ha narrato Pirandello?
«In effetti la domanda è, appunto, “enorme”. Cercherò una significativa sintesi. Giunta, come sono, al tempo in cui si comincia a fare bilanci e si sente il bisogno di memoria, alla domanda: “da dove nascono le tue storie”, non posso che rispondere che le mie storie nascono dalla mia storia. La mia adolescenza e la prima giovinezza furono pressoché tranquille e avvolte di tenerezza in un discreto benessere. La mia era una famiglia di quelle classificate di sani principi. Di conseguenza, da quel crinale tra ragazze per bene e ragazze per male, concepito da una società misogina, abitare tra le ragazze per bene – studiose, obbedienti, pudiche e ignare di “gioie corporali” – mi dava il senso che tutto fosse nell’ordine delle cose. Quell’ordine che, senza sospetti da parte mia se non una certa inquietudine, mi aveva avvolta e plasmata. Come, per esempio, rivestire, a scuola, il proprio corpo con un grembiule nero, a differenza dei nostri compagni maschi, attendere ansiose, nelle feste, l’invito a ballare per non subire la mortificazione di quel che si diceva: “fare tappezzeria”. Essere oggetto di una scelta, di una attenzione, uno sguardo maschili per sentirsi vivere ed esistere. Essere oggetto di un discorso tra uomini legittimato dalle leggi. D’improvviso, tutto ciò prese a mostrarsi, ai miei occhi, nella sua “infamia” ma non sapevo da che parte cominciare quando un giorno suonò, anche per me, come per tante altre donne, “la campanella della ricreazione”: il Femminismo. Una compagna d’università, che vestiva in modo strano, mi disse: “Lo sai che il ratto delle sabine è stato uno stupro collettivo?” Fu un colpo. Quali inganni si celavano in tutto ciò che era stato oggetto dei miei studi diligenti? Una nuova visione mi affollò la mente e tutto mi apparve come il primo anno del mondo! Lentamente percepivo, con stupore, che stesse per cominciare la più bella stagione della mia vita. Pur senza avere ancora il coraggio della parola, presi a partecipare, con meraviglia, a quel modo nuovo di pensare. Talvolta le discussioni si facevano accese ma con lo slancio di nuove consapevolezze. La sessualità, i ragionamenti sul corpo, la discriminazione, l’ineguaglianza, il dominio patriarcale erano temi sui quali non si finiva di discorrere. Così come la narrazione dei doveri femminili del nostro privato anche intimo, strappati dall’alveo segreto da sempre costretti, venivano spudoratamente innalzati a dimensione pubblica se non decisamente politica. Parlavamo di libertà femminile, cominciammo a far luce sui nostri desideri. Collettivi, gruppi di autocoscienza, manifestazioni, slogan gridati a gran voce per affrancarci da millenni di sopraffazione. Con la singolarità del gesto e della parola abbiamo messo in discussione codici atavici, saperi costituiti. La storia, la letteratura, l’arte, il cinema divennero oggetto di studio, ricerca e revisione. Era tutto da emendare, riscrivere, revisionare. Riportare in vita le donne precipitate nelle scorie della storia. È stato questo il processo attraverso il quale tante donne sono diventate oggetto delle mie storie. Quelle voci tutte femminili che venivano verso di me o che io cercavo avida, le loro vite e i loro luoghi divennero per me oltremodo desiderabili oltre che indispensabili».
Come si concilia, per te, lo sguardo dell’artista e il sé autobiografico, che spesso ha a che fare con il racconto del corpo e dell’esperienza?
«Dico subito che ritengo non possa esistere divisione tra l’artista e la sua opera. Da quei gloriosi anni ’70 ad oggi la mia storia e le mie storie – racconti, romanzi, sceneggiature, regie con il mio sguardo creativo sul mondo – non hanno mai deviato dal percorso di quella vicenda epocale. Da quel tempo in cui, acquisita consapevolezza del mio “essere donna”, mi afferrò un “furore”, un bisogno incontenibile di attraversare i saperi e narrare le donne, metterle al mondo con la scrittura, la cinematografia, le attività culturali, la costituzione di associazioni, tra cui la Società Italiana delle Letterate. Le mie “donne” che siano invenzione narrativa o segni oscurate dalla storia, si rivelano e si appellano a me per prendere corpo e uscire dall’oblio. La loro esperienza di vita diventa la mia e i nostri corpi si fondono nella comune consapevolezza di appartenere ad un genere discriminato. È un richiamo misterioso che, con tante altre donne, per anni, abbiamo imparato a riconoscere. Siamo state e siamo una schiera che costruisce, finalmente, una incommensurabile genealogia femminile. Ed è con questa disposizione che ho narrato la vita di Anna Valdina nell’ultimo mio romanzo, Lo scandalo della felicità. Così che interrogando o inventando la vita di Anna Valdina interrogavo e narravo me stessa. Il suo tempo di allora è diventato il mio tempo e il nostro tempo dell’oggi e viceversa. Ma lungi dall’essere una autobiografia la mia opera deve e vuole essere una pedagogia. Ecco cosa voglio per la mia “storia” e per ogni mio lavoro che siano una pedagogia che si traduce in politica».
Pensando al tuo occhio filmico e alle scelte originali da te compiute nell’ambito della diffusione di culture e saperi (ricordo, a chi ci legge, che sei stata pioniera dei cineforum in lingua originale a Catania, alla fine degli anni Settanta), mi viene in mente di chiederti in che modo, nel mondo odierno, è ancora possibile affinare il proprio sguardo, non accontentandosi delle rappresentazioni che ci vengono proposte. Quali visioni del mondo ci mancano ancora? Quali ti vengono in mente quando scrivi?
«Decenni di impegno politico, attraverso il mio occhio sul mondo, sono diventati il mio tempo dell’oggi. Un tempo povero di quelle visioni del mondo che in tante avevamo immaginato e lavorato per costruire la marcia verso la libertà. Oggi, in un tempo in cui sento il piacere doloroso della memoria, più che la malinconia per la mia giovinezza, mi affligge la consapevolezza delle trame confuse in cui tutta quella esperienza è andata ad infrangersi. Il patriarcato, con il suo sistema misogino e i suoi potenti mezzi mediatici, se dapprima ha reagito veicolando il disvalore della “poetica” femminista, successivamente, soprattutto negli ultimi decenni, con il crescere delle libertà femminili, ha alzato gli scudi, ha lanciato delle controffensive palesi o subdole. Accanto ad un maschilismo tradizionale intravvedo serpeggiare un sessismo benevolo e subdolo e accanto a poche conquiste si continua ad operare discriminazioni non sempre riconoscibili. Oggi vedo millantare traguardi di rappresentanza, dicasi briciole, offrendo lo spettacolo di una equivoca emancipazione ad un femminile ignaro o immemore dei ragionamenti sulla differenza, la liberazione, l’autoriconoscimento. Per non dire di quel femminismo che si è relegato in un letargo talvolta litigioso e confuso sulla visione del mondo, tra molteplici identità plurali spacciate per fluidità. Un femminismo immemore del suo strumento di lotta privilegiato: l'”epopea” della irriducibile differenza femminile. Così, identità di genere, gravidanza per altri, sex work, farmaci per bloccare la pubertà, trans che occupano gli spazi delle donne, con il pretesto neoliberista dei diritti e sono diventatati la questione chiave del mondo odierno riportando il femminile ad un neutro universale. Un femminile così tornato ad essere mescolato nella “vulgata” maschile e distolto dalle sue proprie battaglie. In un panorama dell’universo esistenziale femminile così turbato bisognerà tornare ad “affinare lo sguardo”. E se assistiamo ad una massiccia presenza femminile in molti settori della società, a ciò non corrisponde la possibilità di incidere negli equilibri del potere. E quelle donne che sono entrate a far parte delle “agende” politiche spesso sono destinate, per inconsapevolezza o imposizione, a posizioni ancillari e chiamate ad una assoluta complicità con i piani del potere se non oggetto di trattative tra i partiti. Ed eccoci/mi ancora a dar voce, forse ormai rauca, al nostro “canto libero” perché ora più di prima “La lotta non è finita”. È ormai tempo di rompere l’abitudine di molto femminismo di fermarsi alla narrazione del disagio, alla protesta sterile e alla lamentazione senza mai giungere alla proposta e all’azione. Nonostante nel nostro privato e nei gruppi di riferimento abbiamo raggiunto quella libertà a cui anelava il nostro cammino di femministe, sento che altre visioni siano possibili se non indispensabili. Abbiamo raggiunto la parità sul piano formale, ma non su quello sostanziale. Bisognerà quindi perseguire l’impensato, anche senza garanzie, per affacciarci comunque in un mondo che è tutto da fare o da rifare. E credo che questo potrà accadere solo quando noi, le nostre figlie e i nostri figli, la nostra vicina di casa e suo marito, il nostro caporedattore e la sua segretaria, la donna che fa la spesa al supermercato o che si occupa dei nostri anziani genitori, la bambina che viene indottrinata dalla sua maestra, e tutti gli uomini che sono al potere si troveranno di fronte ad una rappresentanza divisa equamente tra uomini e donne. Potrebbe accadere quando vedremo scorrere le immagini di tante donne sui banchi della politica, un numero di donne pari se non oltre alla guida delle istituzioni, delle multinazionali, della finanza, dei partiti, quando i nostri figli e le nostre figlie porteranno anche il cognome della madre, quando le vie delle nostre città porteranno il nome di tante donne taciute dalla storia, dalla letteratura, dalla scienza e dalle arti. E ancora quando tutti e tutte nomineranno le donne nei discorsi privati, istituzionali, e didattici, quando nessun uomo maltratterà o ucciderà una donna. Allora ci sentiremo fieri di aver creato una vera democrazia. Solo allora avremo la coscienza che possiamo prendere in mano il mondo e starci dentro come soggetti liberi. Condivideremo in ugual misura questa libertà con le nostre madri, sorelle, zie, amiche e mogli».
Ripercorrendo le tue narrazioni, da Desiderio allo Scandalo della felicità, emerge la costante della disobbedienza e della dissonanza rispetto alle norme, ma anche una ricerca continua di libertà, appunto, nella felicità. Senti che questo tuo percorso sia affine a quello della gioia di cui ci parla Goliarda Sapienza? In che modo, se è avvenuto, questa scrittrice nostra conterranea ha influenzato la tua prospettiva sulle donne e sul femminismo?
«Il mio incontro con Goliarda è avvenuto in un tempo assai recente del mio percorso di donna “consapevole”, così che piuttosto che influenzare la mia “prospettiva sulle donne e sul femminismo”, l’ha legittimata. Una legittimazione gloriosa nel segno della libertà femminile contro il portato di una cultura maschile, di una creatività maschile che forma, seduce e induce l’immaginario comune e passa indisturbata come neutra. Cioè come una narrazione che racconta il mondo degli uomini e delle donne. Falso. Perché molta di quella rappresentazione è specchio, più o meno permeabile, delle ossessioni, dei desideri maschili che inventano, deformano, amplificano le immagini femminili e la loro rappresentazione. Goliarda Sapienza ha frantumato quella narrazione, quella rappresentazione. Da lei e con lei sento nascere e vivere la consapevolezza e la messa in “scena” del desiderio, del sogno, della fantasia, della libertà nel rapporto con la creatività e l’autorialità dell’irriducibile differenza femminile. Con lei mi si è, ancor più, rivelato il mio proposito di usare le immagini e la scrittura per entrare senza veli o sovrastrutture nel mondo delle donne, raccontare il non detto, l’indicibile e l’invisibile delle loro vite. Dare agio all’alveo di una genealogia femminile da cui emergono donne di eccellenza. Con lei ho immaginato un futuro “luminoso”, di chi vi getta dentro il cuore e sé stessa trasformando il vissuto di pena delle donne in un vissuto di gioia, libertà e splendore».
“Libellulə” è un progetto che nasce dalla sinergia e dalla contaminazione di quattro donne: Silvia Grasso, Venera Leto, Laura Lipari e Serena Todesco. Attraverso la ricerca, la scrittura, i libri e la passione l’intento comune è far emergere aspetti poco noti del mondo letterario femminile e in generale di soggettività che vengono relegate ai margini. L’obiettivo è porre un focus su tematiche attuali e far riflettere sulla necessità di instaurare un dialogo tra i generi e modificare alcuni retaggi culturali. Il titolo è un omaggio a “La Libellula” di Amalia Rosselli ed è un augurio di leggerezza ed equilibro per chiunque lotti per la propria autodeterminazione. Qui le altre interviste.