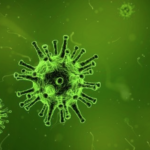Dal blog HomoSum di Francesco Carini
In quel momento si è inserito pienamente in questa ricerca di verità che c’era in Italia e che faceva capo a “Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi. Io, però, non mi sentivo un neorealista, mi sentivo soltanto un realista, uno che dava conto di una determinata realtà, in un determinato paese siciliano.
(Leonardo Sciascia in riferimento a Le parrocchie di Regalpetra, dall’intervista al programma Binocolo, 1984)
Il 24 gennaio ricorre la Giornata Internazionale dell’Educazione, 16 giorni dopo l’anniversario della nascita di uno fra i più grandi scrittori italiani: Leonardo Sciascia.
Nato a Racalmuto l’8 gennaio 1921, l’autore crebbe fra questo comune dell’agrigentino e Caltanissetta (dove frequentò le scuole superiori), vedendo in pieno la miseria e la violenza a cui zolfatari e salinari erano sottoposti. In un’economia che dipendeva in parte dall’agricoltura, in gran parte dall’estrazione dello zolfo e del sale, le condizioni dei lavoratori erano a dir poco misere, costituendo l’humus delle “denunce” de Le parrocchie di Regalpetra, opera attraverso la quale il Maestro è riuscito a fornire uno spaccato della vita nella provincia siciliana, inserendo pure una biografia dei suoi primi 35 anni di vita.
Pubblicato da Laterza nel 1956, il romanzo rappresenta un piccolo gioiello in cui Sciascia descrive mirabilmente le condizioni economiche e sociali del contesto vissuto, soffermandosi sulle cause e sulle conseguenze dello sfruttamento e dell’indigenza delle classi subalterne. Regalpetra non esiste nella realtà, ma riassume le caratteristiche di Racalmuto e prende il nome anche da Petra, utilizzato circa 20 anni prima da Nino Savarese per indicare Enna.
Uno fra i pilastri fondamentali dell’opera è costituito dalle “Cronache scolastiche”, pubblicate dalla rivista “Nuovi argomenti” l’anno precedente e proprio gli studenti sono gli oggetti principali dell’analisi di Sciascia, osservati durante la sua carriera di insegnante fra gli anni ’40 e ’50.
Oltre al realismo, necessario e fondamentale per portare a galla le cause e gli effetti delle ingiustizie su migliaia di esseri umani costretti a sopravvivere più che a vivere, traspare in alcuni tratti un lirismo e la tenerezza di un giovane insegnante relegato a un ruolo d’ordine, perché tale era quello del maestro in classi di diseredati che spesso andavano a scuola più per la refezione che per imparare. Ma proprio qui sta la grandezza di Leonardo Sciascia, capace di illustrare e sviscerare il problema e non di dare semplicemente la colpa ai suoi ragazzi, la maggior parte dei quali erano forgiati a una “cattiveria” e un’ineducazione figlia della fame atavica e di una violenza sia simbolica che reale protrattasi su intere generazioni e famiglie, che nel loro immaginario vedevano non di rado nei maestri l’avamposto del potere che li obbligava a un’esistenza fatta di stenti e subordinazione, situazione (per alcuni versi attuale) per cui potevano scorgere un esempio positivo in un bandito come Salvatore Giuliano, piuttosto che in un carabiniere, che fino a qualche tempo prima rappresentava invece uno fra i pochi lavori sicuri più ambiti.
Questi diseredati percepivano nell’istituzione scolastica non il mezzo attraverso cui essere inquadrati o elevarsi sotto il profilo socio-culturale, bensì il luogo in cui venivano perpetrate diseguaglianze già preesistenti e dominanti anche tramite l’autorità pedagogica costituita dagli insegnanti. I proletari di Sciascia non si portano dietro un habitus volto alla cieca obbedienza (per citare Bourdieu, autore di quello straordinario saggio che è La reproduction), come un automatismo forgiato sin dall’infanzia nelle scuole, bensì una rabbia che può esplodere da un momento all’altro, nonostante tali exploit, frutto di secoli di sottomissioni, abbiano avuto pochi risultati concreti considerando l’evoluzione storica e sociale del contesto preso in considerazione, oltre le dure punizioni per chi ha osato mettere in discussione l’ordine prestabilito.
Sicuramente, non era un insegnante semplicemente fiero della sua posizione economica e sociale, che se ne andava volentieri in giro durante il sabato fascista:
«in gloria con la divisa di gabardina e il berretto col giummo», mentre «i contadini ed i salinari che ci guardavano con tanto d’occhi».
Le critiche per gli automatismi e la cieca burocratizzazione che non teneva conto dei drammi quotidiani di migliaia di individui e famiglie che non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, con alcuni padri che rischiavano di finire in camera di sicurezza magari per non aver potuto mandare i figli a scuola, lo rendevano capace di simpatizzare per chi lo odiava a causa della sua funzione, tentandolo addirittura a mettersi: «dalla parte di quelli che non volevano mandare a scuola i figli, di consigliarli a resistere, a sfuggire all’obbligo».
Conscio che un “pezzo di carta” logora chi non ce l’ha, ovviamente il sentimento principale che sorgeva nello Sciascia de “Le parrocchie di Regalpetra” non era quello di spingere i genitori a non garantire l’istruzione ai propri figli, bensì di critica verso un apparato di controllo inflessibile con i deboli, e debole con i potenti, insensibile davanti al grido disperato più o meno espresso di povera gente a cui non venivano garantiti i mezzi per permettere ai propri figli un’infanzia serena, in cui verosimilmente l’obbligo scolastico potesse diventare primario rispetto al timore di non poter soddisfare i bisogni essenziali.
Al contrario di alcuni noti intellettuali di oggi, la sua umanità non era ad orologeria. Comprendeva (che non significa “giustificava”) il collegamento che poteva sorgere automatico fra parte dei ceti più poveri, i quali vedevano due facce della stessa medaglia nel maestro e nel maresciallo dei carabinieri che spediva in camera di sicurezza chi non mandava (o non poteva mandare) i bambini a scuola. In egual modo, restava segnato dall’ignoranza e dalle violenze subite come quelle a cui era sottoposto un suo alunno, percosso dal padre perché diceva, a ben ragione, di non vedere bene, situazione reale che gli impediva di adempiere in modo adeguato anche alla lettura per la mancanza di un semplice paio di occhiali da vista.
Il cruccio di Sciascia era quello che:
«si finisca come quel mio collega anziano che non se ne cura, come se i ragazzi fossero numeri. Forse è come quando si entra in una sala anatomica […]. Se io mi abituerò a questa quotidiana anatomia di miseria, di istinti, a questo crudo rapporto umano; se comincerò a vederlo nella sua necessità e fatalità, come di un corpo che è così fatto e diverso non può essere, avrò perduto quel sentimento, speranza e altro, che credo siano in me la parte migliore».
Pertanto, ci troviamo di fronte a un dramma interiore reale che pervade l’animo di Sciascia, connesso al timore di perdere la sensibilità verso situazioni difficilmente immaginabili in società in cui il benessere è diventato la norma (almeno prima dell’ultimo decennio). Il genio di Racalmuto soffre osservando le condizioni socio-economiche di partenza della maggior parte dei suoi alunni, i cui comportamenti sono quasi sempre dettati da fattori ambientali e, pur analizzando con lucidità pressoché scientifica il contesto, non perde quel tratto di umanità insita nell’uomo, prima che nell’insegnante.
Leonardo Sciascia, nato l’8 gennaio di cento anni fa, in questa pubblicazione è stato capace di descrivere con intelligenza “chirurgica” alcuni lati oscuri di una regione (e, se vogliamo, di un paese) in cui il mantenimento dello status quo e lo stigma sociale nei confronti dei diseredati non è stato combattuto con adeguate politiche atte a limitare diseguaglianze, spesso cause dei fenomeni che sono poi stati repressi con un grottesco zelo.
La commuovente umanità di Sciascia si intravede ancor di più nell’ultima parte del romanzo (cap. La neve, il Natale), dove, illustrando situazioni raccontate da alcuni suoi studenti relative alle loro vacanze di Natale, si sofferma su quella straziante di un ragazzo “defraudato” dal padre delle 200 lire della vincita a carte con i cugini e gli amici, scrivendo:
«Non ho mai letto niente di più triste nelle cronache, spesso desolate, che i ragazzi mi fanno delle loro giornate. Vedo la casa, umida e scura in quel quartiere di San Nicola che è il più povero del paese; il ragazzo piangente (e magari avrà avuto qualche ceffone e qualche cattiva parola) per quelle duecento lire che si era buscate al gioco e che voleva spendere chi sa come, magari per avere i quaderni e la penna, e il padre che se ne va a farsi il bicchiere, ad ubriacarsi con i poveri quattrinelli del suo bambino. Mai, come attraverso questo piccolo fatto, la miseria mi è apparsa in tutta la sua essenza di cieca e maligna bestialità.
A guardar bene, ci sono nell’episodio tutti gli elementi che fanno la tragedia della nostra vita – e almeno della mia vita fin qui – in questo povero paese. Ed il giorno della grande festa cristiana, che fa da sfondo e condiziona l’episodio, pare diventi, dietro questo bambino che piange nella sua casa oscura, una blasfema parodia».
Di Sciascia ne nascono pochi, ma la capacità di emozionarsi e di provare empatia verso chi soffre (situazione che lo accomuna, con le dovute differenze, a giganti quali Pier Paolo Pasolini) dovrebbe essere la conditio sine qua non di chi lavora nel mondo della scuola, soprattutto di chi si trova davanti a contesti disagiati nei quali la povertà costituisce la norma, di cui i ragazzi sono solo vittime, con tutti gli effetti che ne conseguono (compreso il potenziale avvicinamento alla criminalità organizzata).
L’articolo prosegue su HomoSum a questo link
©️Francesco Carini – tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale.