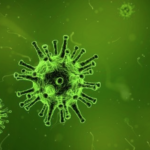di Francesco Carini – Homo Sum
Qui il link all’articolo pubblicato su Homo Sum e qui la mission del progetto.
La Resistenza italiana ha avuto un ruolo tutt’altro che insignificante per la vittoria alleata. Le bande armate che hanno fatto la Resistenza al Nord, occupando le valli e le colline, bloccando vie di comunicazione, liberando e governando per mesi interi territori, rendendo la vita difficile ai presidi tedeschi e fascisti, sono arrivate in certi momenti a tenere impegnate fino a sette divisioni tedesche. […] Il comandante di tutte le forze alleate nel Mediterraneo, il generale Alexander, disse che aveva cominciato a rispettare gli italiani, all’indomani dell’attacco di via Rasella, quando aveva scoperto che Roma – cito – era una città che ha osato sfidare in pieno centro un battaglione tedesco armato. E dunque, l’idea che la Resistenza abbia avuto poco o nessun peso in termini strettamente militari è da relegare nell’armamentario dei luoghi comuni […].
(Prof. Alessandro Barbero, Vercelli, 25/04/2019)
Queste sono le parole dello storico e prof. Barbero (Università degli studi di Torino), pronunciate lo scorso anno a Vercelli il 25 Aprile, in occasione della Festa della Liberazione. Il discorso è molto più amplio e incentrato anche sull’apporto dei partigiani meridionali, con personaggi divenuti epici, quali il siciliano Pompeo Colajanni, che identificano la Resistenza come un fenomeno nazionale.
In un periodo in cui è importante che si evitino assembramenti e tutti si impegnino a salvaguardare la salute propria e di chi ci sta intorno (aspetto sottolineato anche da iniziative virtuali promosse dall’ANPI sul proprio sito), si può studiare la Resistenza leggendo, o guardando film incentrati su questo fenomeno che coinvolse l’Italia fra il 1943 e il 1945, senza dimenticare comunque importanti attività antifasciste precedenti a questo periodo, non basate su azioni militari, bensì intellettuali, e che videro le barbare uccisioni di personalità quali Giacomo Matteotti e Piero Gobetti, o la prigionia di Antonio Gramsci, verso cui il pm fascista Isgrò, nel giorno della condanna così si espresse:
«Bisogna impedire a quel cervello di funzionare almeno per vent’anni»
Anche il cinema ci ha regalato grandi emozioni, riuscendo a inquadrare il fenomeno della Resistenza piuttosto bene. Oltre ai tre capolavori di Roberto Rossellini: Roma città aperta (1945), Paisà (1946) e Il generale della Rovere (1959), possiamo citare Achtung! banditi! di Carlo Lizzani (1951), La lunga notte del ’43 (1960) di Florestano Vancini, Le quattro giornate di Napoli (1962) di Nanni Loy e soprattutto I sette fratelli Cervi (1968) di Gianni Puccini, che vide la partecipazione di Gian Maria Volonté e Riccardo Cucciolla, straordinari nell’interpretare rispettivamente il ruolo di Aldo e Gelindo Cervi, con i due attori nuovamente insieme dopo aver recitato in Sacco e Vanzetti a teatro nel 1960 (e lo saranno anche nel 1971 sul grande schermo, nell’omonima opera di Giuliano Montaldo).
Se c’è una storia in grado di riscoprire il valore della Resistenza è propria questa dei 7 fratelli emiliani, barbaramente torturati e giustiziati il 28 dicembre del 1943, dopo essere stati arrestati per la loro attività di partigiani, che nulla ha in comune con isolate azioni di alcuni ex combattenti che, al termine della guerra, hanno compiuto esecrabili atti di giustizia sommaria, in spirito totalmente antitetico rispetto agli ideali della Resistenza.
Ma, tralasciando a malincuore la settima arte, in cui fiction e realtà possono mescolarsi in modo inestricabile, è soprattutto la storia la disciplina che deve spiegare i tratti peculiari di ciò che è stata la Resistenza e chi sono stati i partigiani, soprattutto per evitare che le Fake News circolanti via social prendano il sopravvento sulle ricerche serie, realizzate dopo anni di studi sul tema.
Oggi, il prof. Cesare Panizza (docente a contratto di storia contemporanea presso l’Università del Piemonte Orientale), vincitore del del Premio Giacomo Matteotti nel 2019 (indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e ricercatore presso l’ISRAL di Alessandria, risponde ad alcune domande, per la rubrica Parola all’Esperto, su un argomento che, soprattutto negli ultimi tempi, sembra stia diventando un tabù, dando l’impressione che il ricordo della liberazione dell’Italia dai nazifascisti dia parecchio fastidio a una parte della popolazione, fomentata anche dalla politica.

Buongiorno Cesare, da quanto tempo ti occupi di Resistenza e su quali aspetti si sono incentrate le tue ricerche?
Da un certo punto di vista, affettivo, direi da sempre. Entrambi i miei nonni erano partigiani e i loro genitori a loro volta erano coinvolti nel movimento. Si può dire che la mia stessa passione per la storia venga da lì, dalle memorie famigliari, peraltro quasi sempre declinate da mio nonno paterno in termini picareschi, avventurosi… Da un punto di vista “professionale” me ne occupo dai tempi della tesi di laurea, da quando ho cominciato a studiare l’antifascismo e a collaborare con l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”.
Si può parlare di “avvelenamento di pozzi” nei confronti della lotta partigiana? Se sì, da dove parte secondo te e come si è evoluto negli anni?
Il tentativo di leggere in negativo la vicenda resistenziale è quasi immediatamente successivo al dopoguerra ed è naturalmente legato all’esplodere della guerra fredda. Essa offre l’occasione non tanto e non solo ai fascisti di contrapporre una loro memoria di quanto accaduto e di ritornare in politica con il movimento sociale, ma ai settori conservatori che votano per la DC magari con qualche sospetto, permettendo di proporre una propria narrazione della storia d’Italia largamente concorrenziale con quella dei partiti e degli intellettuali antifascisti che conosce ben inteso fenomeni simili di suo pubblico e politico… Non bisogna dimenticare i tanti processi che i partigiani subiscono in quegli anni e che, al di là delle singole vicende processuali, agli occhi dell’opinione pubblica moderata sembrano voler processare la Resistenza nel suo insieme. E indubbiamente un avvelenamento dei pozzi lo producono, eccome. Anche sul piano storiografico, per esempio con il divaricarsi nel racconto di quegli anni fra Resistenza da un lato e militari italiani internati nei campi di prigionia in Germania dall’altro….
Non ci dobbiamo stupire dunque che ancora oggi la cultura di destra legata con la memoria del fascismo continui a proporre una qualche forma di demonizzazione della Resistenza, o tenti di sminuirne il ruolo. Oppure tenti di promuovere equiparazioni fra i partigiani e i ragazzi di Salò, partendo dalla banalità di osservare come anche fra i partigiani vi fossero delle mele marcementre fra i fascisti ci fossero persone in buona fede, dimenticando la distanza siderale fra i valori e i programmi politici per cui quelle persone combattevano. Come ci ricorda Italo Calvino non dobbiamo mai dimenticare che:
«Dietro il milite delle brigate nere più onesto, più in buonafede, più idealista, c’erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l’Olocausto; dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c’era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta se non proprio giusta in senso assoluto, ché di queste non ce ne sono».
Di cosa si occupa e qual è l’obiettivo del tuo ultimo libro?
Intanto il titolo: “Dalle belle città date al nemico. Il partigianato in provincia di Alessandria”, è un tentativo di ricostruire il profilo socio-demografico del partigianato sul territorio alessandrino. Da qui anche la citazione contenuta nel titolo del libro: dalle belle città date al nemico è l’incipit di una nota canzone partigiana, una delle poche in cui anche la musica sia originale e non sia il riadattamento di un tema precedente, composta da due partigiani genovesi militanti nella III brigata Liguria stanziata sul nostro Appennino, al confine fra territorio alessandrino e genovese. Mi sembrava una citazione doverosa e opportuna perché appunto il libro, prendendo in esame un territorio molto ampio, addirittura un’intera provincia, vuole rispondere alla domanda: chi sono i partigiani? La fonte utilizzata è il database “Partigianato piemontese e società civile”, consultabile sul sito dell’Istoreto, in cui a metà anni Novanta sono state riversate le schede dei richiedenti qualifica partigiana dopo la fine del conflitto. Qualcosa che si avvicina, pur non essendola, a un’anagrafe del movimento resistenziale. Non lo è, perché molti partigiani dopo la guerra non vollero alcun riconoscimento…
Quali sono gli elementi di novità che questa ricerca può portare agli studi sulla Resistenza, non solo a livello locale?
Da un lato la sistematicità con cui ho cercato di interrogare questa fonte, che in futuro sarà ancora più preziosa. Sta nascendo un database nazionale del partigianato che sarà ancor più ricco di informazioni. Solo il databasepiemontese è costituito da 109.000 schede, da cui io ho ricavato gli “alessandrini”, all’incirca 10.000 (a seconda dei criteri assunti per definirli). Al di là di ciò e al di là degli aspetti più propriamente locali di un territorio quale quello alessandrino, che risente delle dinamiche tipiche di un’area di confine e di passaggio, fra: Piemonte, Lombardia, Liguria, e in fondo anche Emilia, e che nei “venti mesi” risente di una massiccia presenza del nemico che presidia una zona strategica per le comunicazioni fra valle padana, costiera ligure e immediate retrovie della gotica (non è un caso che la più grossa strage nazifascista del Nord-Ovest avvenga qui, alla Benedicta), direi che gli elementi interessanti anche a livello nazionalesono diversi. Dall’altro lato, ci restituisce come la Resistenza sia un fenomeno unitario, con caratteristiche ovunque simili, ma al tempo stesso in cui sulla sua composizione hanno un’influenza determinante i singoli contesti locali, anche quelli minuscoli. È interessantissimo per esempio vedere come nei centri minori, nei comuni rurali, la scelta della resistenza sia un fenomeno collettivo, una scelta quasi comunitaria fatta a partire da legami famigliari e amicali (tutti gli appartenenti alle stesse classi di età entrano nel movimento in massa e perlopiù nelle stesse formazioni allo stesso momento); mentre in città, quei percorsi sono molto più complessi e differenziati, e la scelta resistenziale diviene soprattutto un fatto individuale…
A questo proposito è interessante notare come i numeri sembrano sfumare il nesso tradizionalmente istituito fra renitenza alla leva di Salò e Resistenza: il 50% dei miei “resistenti” non ha obblighi militari.
Qual è la provenienza del nucleo di partigiani presi in considerazione?
Anche questo è un aspetto interessante: siamo al nord, nel centro geografico del cosiddetto triangolo industriale, eppure la Resistenza è fatta in maggioranza da persone provenienti dai piccoli centri e dalle campagne. Ma attenzione, non necessariamente legati all’agricoltura come occupazione. È come se la Resistenza ci desse un’istantanea di una società in profonda trasformazione: i “miei” partigiani sono ragazzi nati in campagna, i cui genitori probabilmente fanno i contadini, ma che pur continuando prevalentemente a risiedervi fanno già lavori “urbani”.
Poi come in un prisma che scompone la luce, la Resistenza ci restituisce un altro elemento: la presenza già allora di molte persone immigrate nel nord-ovest per motivi economici. Il grosso dei meridionali nella resistenza alessandrina non è composto – come accadrebbe probabilmente se ripetessimo la stessa operazione per le vallate del cuneese – da soldati sorpresi l’8 settembre del ’43 a nord di quella che sarà la linea Gustav, ma di “emigrati economici” già radicati in quei luoghi.
Il caso dei veneti è ancora più evidente. È una conferma di fenomeni di cui mi ero già occupato con altre ricerche: sono i prodromi, celati dalla retorica del regime fascista che tenta di limitarne la portata, della grande trasformazione demografica che il nostro paese conoscerà negli anni del boom economico.
Nel caso alessandrino proprio studiare i partigiani del nostro territorio ci fa vedere come nella società dell’epoca ci fossero dei meccanismi di compensazione di questo tipo: moltissimi resistenti alessandrini risultano partigiani in formazioni torinesi perché hanno lasciato le campagne della nostra provincia per la grande città industriale, al loro posto in quelle campagne arrivano persone da altre regioni, soprattutto dal Veneto e dal Mezzogiorno.
Facendo un discorso più amplio, legato sia all’ambito territoriale piemontese che non, qual è stato il contributo alla Resistenza dei partigiani meridionali, anche in termini numerici? E qual è il rapporto (sempre numerico) rispetto a quelli settentrionali?
Nel 2015/2016 assieme ad altri ricercatori ho collaborato alla revisione del database partigianato piemontese promossa proprio con l’obiettivo di estrapolarne i meridionali. Sono circa 8000 i nominativi che abbiamo rintracciato, meno del 7,5%. Attenzione però è probabile che il dato sia sottostimato, dal momento che molti partigiani meridionali una volta rientrati al Sud, in ambiente meno favorevole alle memorie partigiane, sembrano non aver fatto richiesta di qualifica….
Il primo episodio di ribellione potrebbe essere considerato quello delle “Quattro giornate di Napoli”? O ce ne sono stati altri?
Al Sud è il primo di grande rilevanza ma ce ne sono anche altri. Più in generale la storiografia – e il discorso pubblico – ha ormai integrato nel racconto della resistenza anche quella offerta dai reparti militari non disposti ad arrendersi ai tedeschi. Penso alla tragedia di Cefalonia.
Una curiosità, qual è stato il contributo, anche in termini numerici dei tedeschi e dei sovietici che si sono uniti alle bande partigiane? Penso a Rudolf Jakobs, nel caso della Germania
Non saprei quantificarlo. Come ti dicevo, nel caso da me studiato, quello alessandrino, quello dei prigionieri di guerra stranieri è un contributo significativo ma comunque nell’ordine di qualche decina di persone. I disertori tedeschi appunto come Jakobs sono naturalmente considerevolmente meno. Il contributo dei tedeschi ha un valore soprattutto altamente simbolico, come è facilmente comprensibile, quello slavo invece è spesso importante anche dal punto militare, dal momento che si tratta spesso di soldati che hanno esperienze pregresse anche nel campo della guerriglia.
Qual è stata nel tempo la posizione della Chiesa in merito alla Resistenza? Sul totale dei sacerdoti, si potrebbe azzardare una “percentuale” o una stima di preti vicini ai “partigiani” e di altri maggiormente legate al Fascismo? Nel primo caso penso a uomini come don Pietro Pappagallo o don Morosini, mentre in riferimento agli altri penso a padre Eusebio o don Calcagno.
Anche questo è tema da approfondire, su cui è difficile dare un giudizio generale. Quanto ai sacerdoti, non diversamente da ogni altro segmento della società italiana, vi si riscontrano le posizioni più diverse. Ma mi pare si possa dire almeno per il basso clero che essi in un certo senso avessero lo stesso orientamento della popolazione civile, fra cui, per quante sfumature di grigio possiamo incontrare e al netto della necessità innanzitutto di sopravvivere, mi sembra che i sentimentifossero generalmente contrari all’occupante tedesco e ai fascisti… Tornando ancora al territorio che conosco, sono molti i sacerdoti simpatizzanti se non schierati con la resistenza, senza neanche star troppo a guardare al colore politico delle bande.
Oltre alla lotta eroica, ci sono stati anche episodi negativi che hanno coinvolto alcuni partigiani. Tali casi, sono maggiormente dovuti a errori o a bande che univano la lotta di Resistenza ad obiettivi meno nobili? Ci sono stati casi di infiltrazione di criminali all’interno della Resistenza?
Certo, non bisogna dimenticare la questione della violenza interpartigianasenza neppure esagerarla però, dal momento che è iscritta nelle coordinate inevitabili del fenomeno.
Da un lato c’è il bisogno politico di amministrare la giustizia nei territori controllati dai partigiani o comunque segnati dalla loro presenza con la necessità di ripulirli per forza da quelle bande che magari, fingendosi partigiani, finivano per razziare le popolazioni civili, senza il cui sostegno la resistenza sarebbe stata impossibile. Dall’altro ci sono episodi di tensioni fra formazioni partigiane di colore diverso, per il controllo del territorio o per le difficoltà di coordinare le operazioni sul terreno, e anch’essi per varie ragioni sono congeniti e inevitabili. Direi però, rovesciando la logica con cui questi episodi sono spesso citati a detrimento della resistenza, che semmai fu un merito della resistenza nel suo complesso riuscire a governare nella maggioranza dei casi quella conflittualità. Anche in questo senso fu una straordinaria scuola di educazione politica.
Da studioso della Resistenza, c’è qualcosa che ti preoccupa in questo momento storico in cui il 25 Aprile come data simbolica viene osteggiata e vista con sospetto? Naturalmente non mi riferisco al festeggiamento puro. E, in qualità di ricercatore, ma anche di padre, cosa ti auguri per il futuro?
Ogni qualvolta che il nostro Paese attraversa momenti critici – e anche questo lo è, e non mi riferisco solo al corona virus – dal punto di vista politico e sociale, la Resistenza e il 25 aprile sono quasi naturalmente oggetto di polemica e di controversia. È quasi un barometro della società italiana. Ora poi questo avviene anche in un momento in cui si va esaurendo per motivi biologici definitivamente la generazione dei testimoni, il che implica anche la necessità di ripensare le forme di trasmissione della memoria.
Lo abbiamo detto prima, ci sono settori, anche ampi, della nostra società che in quella data non si riconoscono e gli negano quel valore di festa nazionale condivisa che invece dovrebbe avere. Questo naturalmente non può che preoccuparmi, come cittadino e come studioso. Da cittadino perché significa negare al 25 aprile il valore di festa nazionale, di giorno in cui si celebrano i valori democratici e significa sostanzialmente non riconoscersi nella democrazia, se non in forma puramente esteriore, come insieme di norme procedurali. Da studioso perché spesso ci si trova in presenza di palesi manipolazioni della nostra storia che celano l’idea che in fondo la storia sia riducibile a pura interpretazione e non sia invece in realtà innanzitutto una scienza, ancorché una scienza umana.
Però fra i negatori o gli spregiatori del 25 aprile bisogna fare una distinzione. C’è chi nega il 25 aprile per un motivo apertamente di parte, perché si ricollega direttamente alla memoria degli sconfitti. Queste narrazioni possono preoccuparmi e certamente da studioso per il discorso fatto sopra, ma non le amplificherei per gli effetti politici. Da cittadino mi preoccupa di più il discorso, come fece Salvini l’anno scorso, di chi riduce ciò che accadde a un derby fra rossi e neri, a qualcosa che insomma non riguardava la maggioranza degli italiani, di chi oggi magari minimizza l’importanza del 25 aprile sostenendo che è acqua passata, che non ci riguarda più.
Queste posizioni mi preoccupano di più perché fanno leva sull’indifferenza che naturalmente, soprattutto nelle generazioni più giovani, può essere prodotta dalla distanza nel tempo che ci separa da quegli avvenimenti. E dalla qualità del tempo trascorso: in settantacinque anni è cambiato tutto, i nostri quadri mentali, costumi, abitudini, eccetera. A un giovane di oggi quel mondo può apparire radicalmente estraneo. Ecco quei ragionamenti, quel ridurre tutto a qualcosa di simile alla vicenda dei guelfi e dei ghibellini mi preoccupa, eccome, perché più insidioso, perché può far dimenticare quale sia il messaggio del 25 aprile.
Che cosa ricordiamo infatti domani? Intanto – ed innegabile – la vicenda che storicamente nel nostro paese ha segnato la nascita della democrazia: non vedo con quale altra dovremmo sostituirla o come si possa negare che in Italia la democrazia non nasca dalla sconfitta del fascismo e dalla vicenda complessiva dell’antifascismo: non si ricorda mai abbastanza che la dittatura di Mussolini è storicamente responsabile nella storia d’Italia di aver ucciso sul nascere la democrazia italiana: il fascismo fu una controrivoluzione sì, ma non contro la minaccia bolscevica – che certo contò nel facilitargli il compito – ma contro la ben più concreta ipotesi di una evoluzione democratica delle istituzioni liberali.
È nella lotta contro il fascismo, prima nella lunga vicenda dell’antifascismo, poi nella resistenza che avviene la maturazione nel nostro paese di una compiuta coscienza democratica. Ed è qui il valore di ciò che andremo a celebrare domani. Il 25 aprile ci ricorda infatti come quei valori e quei beni che diamo per scontati, la democrazia, la libertà, la pari dignità di ogni persona eccetera, siano stati frutto prima di una lunga elaborazione e poi di una lotta faticosissima e tragica la cui posta in gioco – altro che derby fra neri e rossi – era davvero il significato stesso della nostra civiltà. Bisogna dunque – lo dico serenamente, senza allarmismi – vigilare perché questa consapevolezza non venga meno. E operare affinché quei valori siano riconosciuti anche altrove, visto che ci sono paesi del mondo in cui essi sono inoperanti, vilipesi, negati. Per fortuna, sia il lavoro degli storici, sia quello dell’associazionismo – penso all’ANPI – mi fa essere ottimista, da questo punto di vista sul futuro, mi fa sperare che insomma quei fili, anche dolorosi, che ci legano al passato non saranno recisi.
© Francesco Carini – tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale.