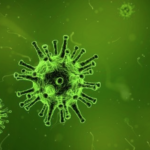Dal blog HomoSum, di Francesco Carini
– Chevalley: […] E anche se lei non ci crede, questo stato di cose non durerà, la nostra efficiente e agile amministrazione cambierà ogni cosa.
– Don Fabrizio, principe di Salina: Non dovrebbe poter durare, ma durerà sempre… Il sempre umano certo, uno o due secoli, e dopo forse tutto sarà diverso, ma sarà peggiore.
Tratto da Il Gattopardo, di Luchino Visconti, 1963
In uno degli anniversari più tristi in assoluto della storia italiana, oltre alle terribili immagini di repertorio della Strage di via d’Amelio e al dolore per le affermazioni del giudice Borsellino ascoltate attraverso la documentazione desecretata della Commissione Antimafia, mi viene in mente una parte del celebre dialogo fra Don Fabrizio e il piemontese Chevallay nel film Il Gattopardo, tratto dallo splendido omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il contesto storico in cui è stata ambientata questa scena era immediatamente successivo all’Unità d’Italia e le parole del nobile siciliano rivolte al funzionario piemontese pesano come macigni, oltre a sembrare per alcuni versi profetiche. Subito dopo il sopracitato scambio di battute, il personaggio interpretato da Burt Lancaster dirà:
[…] Noi fummo i gattopardi, i leoni… Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra.
Il principe, nominando le iene, si riferiva agli individui che sfruttarono gli eventi storici come lo Sbarco dei Mille e la stanchezza del popolo siciliano per il passato regime alfine di ottenere una scalata sociale non volta a cambiare lo stato delle cose, bensì a prendere il posto del ceto aristocratico che ha fondato anche sulla disuguaglianza il proprio secolare potere. Nel Il Gattopardo, l’alta borghesia agraria che sfrutta con astuzia il passaggio dai Borbone ai Savoia è rappresentata da Calogero Sedara (interpretato magnificamente da Paolo Stoppa), che, secondo don Fabrizio di Salina: «[…] più di quello che voi chiamate prestigio, ha il potere. […] In quanto a illusioni non credo ne abbia più di me, ma se occorre è abbastanza furbo per crearsele».
Dall’altro lato, l’aristocrazia isolana si dovrà piegare al nuovo che avanza, sia per questioni economiche, data la disparità a favore dei “rivali”, che per convenienza, alfine di non restare spazzata dagli eventi. Come dirà Tancredi (Alain Delon): «Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi».
E propio il fatalismo che pervade l’azione e il pensiero del protagonista, si traduce magnificamente nella confessione che il principe farà a Padre Pirrone (Romolo Valli):
“Ho fatto importanti scoperte politiche. Sapete che succede nel nostro paese? Niente succede, niente. Solo un’inavvertibile sostituzione di ceti […]. Capite padre, il nostro è il paese degli accomodamenti […]”.
Bisogna partire proprio da questo punto. Spostandoci in un altro ambito e senza alcun sentimento nostalgico (sarebbe grottesco), forse è l’accomodamento ciò che fa più paura nella lotta alla criminalità organizzata da parte della politica, che, escludendo alcune circostanze, non ha fatto abbastanza, ma ha permesso alla mafia nel tempo di cambiare pelle, interessi, settori di investimento, non distruggendola mai, addirittura servendosi in Sicilia nei secoli precedenti di istituzioni quali le Compagnie d’Armi (fondata nel 1543, descritta da storici quale Salvatore Francesco Romano ed inserita da studiosi come Umberto Santino fra i “fenomeni premafiosi”), alfine di tutelare gli interessi delle classi dominanti ai danni di quelle subalterne ridotte allo stremo, il cui spirito civile e l’anelito alla giustizia sociale erano bloccati sul nascere attraverso la violenza. Senza confondere fenomeni sociali e contesti in parte differenti, si potrebbe dire che la Mafia, quella vera, non manifestazioni contigue (per un’analisi specifica ed adeguata purtroppo un articolo non è assolutamente sufficiente), ha compiuto un passaggio da Gattopardo, a Iena (e, a volte, anche pecora), sopravvivendo sempre, magari nascondendosi, ma continuando a influenzare politica, economia e società, non facendo mai niente per niente, con un’organizzazione capillare che nei decenni ha condizionato lo Stato, non permettendo mai in fondo di far sbocciare una reale e meravigliosa democrazia, dove (citando Paolo Borsellino): «sentire subito la bellezza del profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità».
Nello stesso ultimo discorso pubblico del 25/06/1992, il giudice palermitano citò un elemento essenziale per togliere potere alla mafia, che doveva essere ostacolata: «rifiutando dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere».
Quando la società civile si trova nella posizione di opporsi in tal modo a questo cancro in metastasi, verosimilmente si troverà alle corde, ma nel momento in cui un’organizzazione criminale che produce fatturati da miliardi di euro può agire in ambienti nei quali la povertà e le disuguaglianze sono incrementate nell’ultimo decennio e lo Stato Sociale è quasi assente, risulta pressoché impossibile combatterla adeguatamente, perché riuscirà a spostare risorse economiche e migliaia di voti giocando sulle paure e la precarietà degli strati meno agiati della popolazione e sulla collaborazione di professionisti e “galantuomini” che costituiscono quella definita in alcuni ambienti come “area grigia”, in altri “borghesia mafiosa” (concetti propriamente non uguali, riguardo cui ci sono posizioni differenti).
Come ha sostenuto il prof. Salvatore Lupo nell’introibo del suo Storia della Mafia, in Sicilia (ma anche in Italia) non è stata assolutamente calata una cortina sul tema, anzi, ne hanno parlato in molti, ma sempre piegando: “ai propri fini uno strumento concettuale già di per sé impreciso”.
Ma c’è un problema forse più importante, che va oltre. Mentre è stata combattuta la mafia militare, è stato invece fatto molto di meno per ciò che concerne quella in grado di determinare attraverso la politica e la finanza le sorti di uno o più paesi, che, nei secoli precedenti, in ambiente agrario, si rafforzò anche (non solo) attraverso una compenetrazione degli interessi di grandi proprietari terrieri, notabili e campieri, in una commistione di poteri in cui mandanti, intermediari ed esecutori hanno agito impunemente allo scopo di rinforzare le proprie posizioni ai danni della collettività, in particolare dei ceti meno abbienti.
Al contrario, movimenti quali quelli dei Fasci Siciliani dei Lavoratori, furono repressi, nonostante gli incoraggianti risultati riportati dallo storico Salvatore Francesco Romano nel suo Storia della Mafia (1963), e che vedevano una diminuzione della criminalità nelle zone in cui i lavoratori erano appunto organizzati democraticamente. Ma queste iniziative durarono poco sia per una volontà politica con direttive che partirono da Roma (culminata sotto il terzo governo Crispi), che per l’azione delinquenziale di disturbo determinate da gruppi mafiosi locali e guardie campestri come accadde fra il 1893 e il 1894 a Lercara Friddi e Gibellina, con la doppia azione di sicurezza pubblica e privata che a Giardinello culminò in una strage che vide la morte di sette manifestanti (contadini) colpiti da due “fuochi”, come confermato dal rapporto dell’allora ispettore Gervasi. Continui tentativi di delegittimazione e tattiche propriamente terroristiche fecero fallire questo esperimento democratico che partiva dal basso, determinando anche l’arresto e la condanna di veri galantuomini quali Nicola Barbato, mentre per l’eccidio di Giardinello fu assolto per insufficienza di prove (a detta del Romano, nonostante l’esistenza di alcuni rapporti dei carabinieri) Girolamo Miceli, capo delle guardie campestri che fecero fuoco sulla folla di contadini.
Nulla doveva cambiare nelle relazioni di potere, e, come ha scritto Roberto Scarpinato relativamente all’Italia del XIX secolo nel suo Il ritorno del principe(citazione presente in questo articolo pubblicato il primo maggio scorso):
Tutta la ricchezza era concentrata in un ristretto numero di famiglie; al posto della cultura dei diritti esisteva quella dell’elemosina e del favore, uno statuto di cittadinanza era semplicemente inconcepibile.
Continua a leggere su HomoSum cliccando QUI
©️Francesco Carini – tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale.